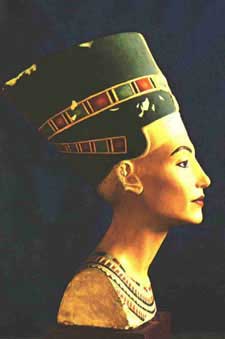Nefertari:
Regina egiziana, chiamata anche Nefretere, la grande
sposa reale di Ramses II il Grande (ca. 1290-1224 a.C.), della XIX Dinastia (1309-1194
a.C.). La regina N. è nota soprattutto attraverso la scoperta della sua tomba nella Valle
delle Regine, avvenuta nel 1904 ad opera del grande egittologo ed archeologo Ernesto
Schiaparelli, sostenitore del Museo Egizio di Torino. Questa tomba è fastosamente
arricchita da splendidi affreschi, tutti strettamente legati al "Libro dei Morti",
che aveva la funzione di aiutare il defunto nel corso del suo passaggio al mondo
ultraterreno. N. vi è raffigurata accanto a
numerose divinità, come Iside, Osiride, Horus, Neith, Ra-Haractes, Hathor-Imentit,
Selkis, Nefti, Mut e naturalmente Anubis. Da varie fonti si sa che la sua prematura
dipartita sollevò un’ondata di immenso cordoglio in tutto l’Egitto, e da
manifestazioni pubbliche del sincero dolore del suo sposo. I suoi funerali furono
imponenti, e videro la partecipazione di tutto il complesso clero e della popolazione. Nel
tempio rupestre di Abu Simbel, dedicato alla dea Hathor, tra i sei colossi della facciata
vi sono ben due statue di N., raffigurata con gli attributi della stessa dea Hathor, nella
seconda e nell’ultima statua da sinistra. Nel suo cartiglio N., raffigurata per
rispetto dopo il geroglifico della dea, è scritto che ella è amata da Mut.
Nefertari:
Regina egiziana, chiamata anche Nefretere, la grande
sposa reale di Ramses II il Grande (ca. 1290-1224 a.C.), della XIX Dinastia (1309-1194
a.C.). La regina N. è nota soprattutto attraverso la scoperta della sua tomba nella Valle
delle Regine, avvenuta nel 1904 ad opera del grande egittologo ed archeologo Ernesto
Schiaparelli, sostenitore del Museo Egizio di Torino. Questa tomba è fastosamente
arricchita da splendidi affreschi, tutti strettamente legati al "Libro dei Morti",
che aveva la funzione di aiutare il defunto nel corso del suo passaggio al mondo
ultraterreno. N. vi è raffigurata accanto a
numerose divinità, come Iside, Osiride, Horus, Neith, Ra-Haractes, Hathor-Imentit,
Selkis, Nefti, Mut e naturalmente Anubis. Da varie fonti si sa che la sua prematura
dipartita sollevò un’ondata di immenso cordoglio in tutto l’Egitto, e da
manifestazioni pubbliche del sincero dolore del suo sposo. I suoi funerali furono
imponenti, e videro la partecipazione di tutto il complesso clero e della popolazione. Nel
tempio rupestre di Abu Simbel, dedicato alla dea Hathor, tra i sei colossi della facciata
vi sono ben due statue di N., raffigurata con gli attributi della stessa dea Hathor, nella
seconda e nell’ultima statua da sinistra. Nel suo cartiglio N., raffigurata per
rispetto dopo il geroglifico della dea, è scritto che ella è amata da Mut.
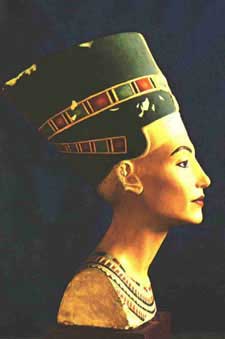 Nefertiti: Nome dal significato egizio di "la
bella che è arrivata", identifica la regina egiziana (XIV secolo a.C.), sposa di
Amenophis IV (Akhenaton, 1364-1347 a.C., v.). Non si limitò ad interpretare il ruolo di
grande sposa reale, poiché il faraone l’aveva coinvolta nella gestione del potere, e
la sua influenza sulla guida politica del regno fu notevolissima. Per questo motivo ella
appare rappresentata con la corona doppia, simbolo del potere faraonico. Dotata di
straordinaria bellezza, è stata ritratta mentre distribuisce doni ai sudditi dal balcone
del palazzo, oppure alla guida del suo carro, nonché nell’atto di colpire con una
mazza il nemico, tutte simbologie di norma riservate al solo sovrano. Nelle lapidi
confinarie N. viene descritta come "dama piena di grazia", e "dotata
di tutte le virtù". Fu tanto oggetto di adorazione popolare da essere stata
talvolta raffigurata come una dea. È famosa per alcune belle opere di scultura che la
raffigurano, e per dei rilievi di epoca amarniana, in cui appare accanto allo sposo, ma
soprattutto per due busti, esposti nel Museo del Cairo ed in quello di Berlino Molto noto
il secondo busto che la raffigura, rinvenuto tra altre numerose sculture, ed ancora
incompiuto, in Akhetaton, nel laboratorio di Thutmosi: ha sul capo l’alto copricapo
blu riservato alla sovrana. È ancora priva dell’occhio sinistro, forse a causa
dell’abbandono frettoloso della città alla morte del faraone. La tomba di N. non è
stata ancora ritrovata..
Nefertiti: Nome dal significato egizio di "la
bella che è arrivata", identifica la regina egiziana (XIV secolo a.C.), sposa di
Amenophis IV (Akhenaton, 1364-1347 a.C., v.). Non si limitò ad interpretare il ruolo di
grande sposa reale, poiché il faraone l’aveva coinvolta nella gestione del potere, e
la sua influenza sulla guida politica del regno fu notevolissima. Per questo motivo ella
appare rappresentata con la corona doppia, simbolo del potere faraonico. Dotata di
straordinaria bellezza, è stata ritratta mentre distribuisce doni ai sudditi dal balcone
del palazzo, oppure alla guida del suo carro, nonché nell’atto di colpire con una
mazza il nemico, tutte simbologie di norma riservate al solo sovrano. Nelle lapidi
confinarie N. viene descritta come "dama piena di grazia", e "dotata
di tutte le virtù". Fu tanto oggetto di adorazione popolare da essere stata
talvolta raffigurata come una dea. È famosa per alcune belle opere di scultura che la
raffigurano, e per dei rilievi di epoca amarniana, in cui appare accanto allo sposo, ma
soprattutto per due busti, esposti nel Museo del Cairo ed in quello di Berlino Molto noto
il secondo busto che la raffigura, rinvenuto tra altre numerose sculture, ed ancora
incompiuto, in Akhetaton, nel laboratorio di Thutmosi: ha sul capo l’alto copricapo
blu riservato alla sovrana. È ancora priva dell’occhio sinistro, forse a causa
dell’abbandono frettoloso della città alla morte del faraone. La tomba di N. non è
stata ancora ritrovata..
Nefertum: Antica
divinità della regione menfita, è il giovane Tum, la personificazione del vecchio
Atum ritornato in vita ringiovanito. Quest'angioletto dell'aurora è seduto su un
fiore di loto, che simboleggia la padronanza sui quattro elementi: il fiore affonda le
radici nella melma del fondale, attraversa l'acqua e sboccia all'aria, sotto l'azione del
fuoco solare. Fu incorporato nella triade dell'antica capitale come figlio di Ptah
e di Sekhmet. Incarna l'eterna giovinezza; è la sostanza vitale, il loto che
nasconde il segreto. Nefer esprime anche uno stato di compiutezza, che da
all'essere la propria potenza generatrice. Nella lingua geroglifica il loto segna l'apogeo
della vita. Nella leggenda di Osiride la corolla del loto serve da scrigno all'Ujat,
l'occhio di Horus (v.), che Seth aveva gettato nelle onde melmose. "Io
sono quel puro loto che esce portando il Luminoso, quello che è attaccato al naso di Ra.
Sono sceso a cercarlo per Horus. Io sono il puro che esce dalla vegetazione
palustre".
Neferty: Autore di una delle più importanti profezie dell’antica letteratura
egiziana (XX secolo a.C.). Sacerdote di Eliopoli, N. visse durante il regno di Ammenemes I
(ca. 1990-1928 a.C.), fondatore della XII Dinastia. La sua profezia, che ha chiari intenti
di esaltazione dinastica, fu scritta per glorificare il sovrano, che avrebbe riportato
l’Egitto al suo antico splendore. Ambientata all’epoca del re Snofru (ca.
2350-2326 a.C.), fondatore della IV Dinastia (ca. 2350-2190 a.C.), predice eventi di un
lontano futuro, peraltro già accaduti nella realtà. Il testo ci è pervenuto completo,
in un papiro ora conservato all’Ermitage di San Pietroburgo.
Nefti: Antica dea sposa
di Seth, madre di Anubi, sorella di Osiride e di Iside, porta
un'acconciatura che la rende inconfondibile: un cesto, che si legge NEB (il Signore), e la
pianta rettangolare del tempio, HET. I due segni uniti si leggono NEB-HET, traducibile in La
Signora del Tempio. È onnipresente nel mito di Osiride, dove si schiera contro suo marito omicida per mettersi al servizio di Iside. Iside rivivifica, e N. stabilizza. Iside corrisponde all'evoluzione, al visibile, N. all'involuzione, all'invisibile. Iside è la sposa di Osiride, N. ne è l'amante. Osiride esiste solo grazie all'azione congiunta delle sue due sorelle, che gli danno modo di manifestare la sua matura divina. La sposa di Seth (l'asciutto, il mattone), N. edifica il tempio con i mattoni, e veglia sulla sua integrità. Può essere paragonata alla forza coagulante alchemica. "Ho concepito
in Iside, ho creato in Nefti. Iside ha cancellato le mie debolezze, e Nefti ha fatto
svanire le mie incertezze".
Negromanzia:
Termine derivato dal greco necroz (morto) e manteia (divinazione), detto anche Necromanzia. Pratica magica
consistente nell'evocazione dello spirito dei defunti allo scopo di consultarli sul futuro
oppure su fatti occulti. Era già ampiamente in uso presso i babilonesi (Epopea di
Gilmanes), gli Ebrei (I Samuele 28, 7-20), i Greci (Odissea 11,
90) ed i romani, la N. sopravvisse ancora nell'Africa equatoriale, nelle Antille e
nel Tibet, oltre che nel moderno spiritismo (v.).
Neith: Antica dea di
Sais, nel delta del Nilo, appare oggi una delle divinità principali del pantheon
egiziano. Il suo nome è traducibile in La Madre del Sole. Androgina, i testi sacri
rivelano che illuminando il proprio sguardo e generando la luce, diede forma agli dei
formulando il loro nome, ossia fissò la loro identità. Creato ed organizzato il
mondo divino, N. si trasformò in pesce e divenne la grande nuotatrice. N. è la vergine guerriera che i Greci chiamarono Atena, armata di un arco le cui frecce respingono le forze del male. È anche patrona di chi tesse il lino, incrociando i fili delle energie. Sempre antropomorfa, è acconciata con la corona rossa settentrionale, ed ha come pianta sacra l'acacia. Secondo il libro dei morti, N. è l'espressione del mistero ultimo della creazione, come testimonia l'iscrizione incisa sul suo tempio di Sais: "Io
sono ciò che è, ciò che sarà, ciò che è stato, ed il mio velo mai nessun mortale ha
sollevato. Il frutto che ho partorito è il Sole".
Nekhbet: Divinità egiziana, di epoca predinastica, protettrice nonché simbolo
dell’Alto Egitto, rappresentata nelle sembianze di avvoltoio. Essendo considerata
protettrice del faraone, il quale la portava sulla fronte del diadema o del classico
copricapo reale, specie sul nemes, accostata alla divinità serpente cobra, Uadjet
(v.).
Neoconfucianesimo: Dottrina filosofica e religiosa fondata da Chu Hsi o Chu Tzu
(1130-1200), soprannominato il San Tommaso d’Aquino (v.) della Cina. Secondo il
Bouquet (Breve storia delle religioni, Ediz. Mondadori, 1952), la sua "è
la più sottile mente metafisica che La Cina abbia mai avuto". Tale dottrina si
sviluppò attraverso tre diverse scuole: 1) Scuola della ragione (920-1279); 2) Scuola
della mente (1338-1644); 3) Scuola della Legge morale (644-1911): Il fulcro intorno al
quale ruota il N. è la dottrina del Grande Ultimo, generatore di Yang (v.), il
principio maschile ed attivo, allorché è nella massima attività, e di Yin (v.),
il principio femminile e passivo, nella stasi assoluta. Tale eterno alternarsi di Yang e
di Yin, genera l’Universo materiale, attraverso i cinque elementi agenti: Acqua,
Fuoco, Legno, Metallo e Terra.
Neocori: Termine
derivato dal greco newcoroz, spazzare, che originariamente,
nell’antica Grecia, designava le persone addette alla pulizia ed alla custodia di un
tempio. In seguito vennero così chiamati i funzionari preposti alla sua cura, con
mansioni sempre più ampie. In genere la carica era di durata annuale. Il titolo di N. era
anche assegnato onorificamente a città devote ad una determinata divinità e, in età
romana, a città che si erano distinte nel culto imperiale.
Neofita: Denominazione
attribuita al neo Apprendista Libero Muratore.
Neoguelfismo: Corrente
di pensiero politico del Risorgimento italiano, che sosteneva come l’unità ed il
rinnovamento nazionali dovessero essere ottenuti con il consenso e per iniziativa della
Chiesa cattolica. A tale conclusione i seguaci del N. giungevano sviluppando il concetto
romantico di cattolicesimo come religione nazionale del paese, e da un’impostazione
storiografica, anch’essa di origine romantica, che vedeva nel Medioevo il momento
formativo della nazione italiana, e nel papato il difensore della sua indipendenza. Le
idee neoguelfe ebbero vasta presa su strati borghesi moderati della società italiana,
sensibili al problema nazionale ma timorosi di sviluppi rivoluzionari, e pronti a vedere
nella Chiesa una garanzia di moderatismo. Trovarono espressione politica nei saggi di
Gioberti su Il primato civile e morale degli Italiani (1841) e Le speranze
d’Italia (1844), con il loro programma di un’unione federale di stati
italiani presieduti dal Papa. L’avvento al trono pontificio di Pio IX rappresentò il
momento di maggior espansione del N., che fu però travolto dai successivi avvenimenti del
1848, che dimostrarono la concreta labilità dei suoi fondamenti, e spinsero i liberali
moderati a fondare le proprie residue speranze solo sulla monarchia sabauda.
Neopitagorismo: Indirizzo
filosofico sorto in Alessandria verso la fine del II secolo a.C. Il movimento tentò di
ridare significato speculativo alla dottrina pitagorica, che sopravviveva ormai solo come
dottrina etico-religiosa, confusa con l'orfismo. Il N. ci ha lasciato un'ampia letteratura
apocrifa, tra cui le Lettere ed i Versi aurei attribuiti allo stesso
Pitagora, e scritti in pseudo-dorico. Appartiene a questa corrente la famosa Vita di
Apollonio di Tiana (III secolo) che cerca di ridare attualità alla filosofia
pitagorica contro l'imperante N.
Neoplatonismo: Indirizzo
filosofico fatto risalire alla scuola di Alessandria, fondata da Ammonio Sacca nel 232
d.C., e che durò fino all'editto di Giustiniano del 529, col quale veniva decretata la
chiusura delle scuole filosofiche ateniesi. Le origini del N. vanno però fatte risalire
al giudaismo ellenizzante di Filone, alle vicende del platonismo medio ed alle suggestioni
delle dottrine mistiche e gnostiche dell'epoca. Il maggior rappresentante fu Plotino (v.),
che fondò la scuola neoplatonica di Roma. Rispetto al platonismo originario, il N. si
differenzia per alcuni motivi metafisici originali. La teoria dell'emanazione,
soprattutto, cerca di mediare i termini sostanziali che Platone s'era limitato a
descrivere, affermando la continuità dell'universo e l'unità delle distinzioni. Una
forte tendenza monistica fa sì che il N. superi l'intellettualismo originario verso una
teologia negativa, che diventa una metafisica dell'inesprimibile, del sovrarazionale, e
riduce il pensiero a realtà di secondaria importanza. Il logos si trasforma da
organo della conoscenza in organo del pensiero negativo, contemplativo e mistico,
terminante nell'Uno-Nulla e nell'estasi religiosa. Tra i maggiori rappresentanti del N.
sono Amelio e Porfirio, discepoli di Plotino, Giamblico e Teodoro di Asine, della scuola
di Siria, Proclo e Plutarco, della scuola di Atene, Edesio e Giuliano l'Apostata, della
scuola di Pergamo. Il N. ebbe grande influenza sul pensiero cristiano e sulla prima
Scolastica. Più tardi, in età umanistica, con la traduzione delle Enneadi effettuata
dal Ficino, il N. divenne un elemento essenziale del platonismo fiorentino.
Neotomismo: Movimento
filosofico cattolico, di rinnovamento della tradizione scolastica, in particolare tomista,
sviluppatosi a partire dall’enciclica Aeterni Patris di Leone XIII (4.8.1879).
I suoi centri erano situati a Lovanio (cattedra di filosofia tomistica, 1889), Friburgo e
Milano (università del Sacro Cuore). Caratteristiche peculiari n sono la polemica contro
le tendenze soggettivistiche ed antimetafisiche della filosofia contemporanea, e la
rivalutazione della tradizione scolastica medievale, riletta alla luce dei problemi della
filosofia moderna. Fra i maggiori rappresentanti del N. sono D. Mercier, J. Maritain, A.,
Gemelli e F. Olgiati.
Nepotismo: termine
che, per estensione, definisce ogni forma di accesso e progressione nelle cariche
pubbliche derivanti dalla detenzione del potere. La definizione di merito ha origine nella
critica alla tendenza largamente diffusa tra i pontefici a favorire i propri congiunti, e
preferibilmente i nipoti. Tale fenomeno può trovare la sua giustificazione storica non
tanto nell’intendimento, da parte del papa, di consolidare ed estendere il potere
della propria famiglia per interessi precisi, quanto alla necessità di crearsi sicuri
appoggi per l’affermazione della propria politica. Dettero esempio di grande N.
Callisto III, che diede la porpora al nipote Rodrigo Borgia (il futuro Alessandro VI), Pio
II; Sisto IV, il quale, in funzione di un programma espansionistico a favore dei suoi
familiari (i della Rovere ed i Riario) ebbe parte considerevole nella congiura de’
Pazzi; il N. assunse le sue più vaste proporzioni con Alessandro VI, che progettava per
il figlio Cesare, già da lui investito del ducato delle Romagne, un grande Stato
italiano. Non ne furono immuni Leone X, Clemente VII, Paolo IV ed Innocenzo XI: tuttavia
quest’ultimo preparò la bolla Romanum decet (Pontificem), pubblicata nel 1692
da Innocenzo XII, con la quale si proibì ai pontefici di concedere uffici e dignità ai
propri congiunti.
Nero: Colore
simboleggiante il regno di Saturno, la purificazione della Terra e la meditazione
profonda. Nel simbolismo dell’Arte cristiana medievale il N. corrispondeva alla
penitenza, come il bianco alla purezza ed il rosso alla carità. L’Ouroboros (v.) ha
la metà superiore del corpo di colore N., e quella inferioredi colore bianco. In molte
teologie orientali il N. indica la materia prima, Prakriti. Nella Bhavavad-gita
(v.) Krishna (v. Avatara) viene rappresentato di colore scuro, mentre Arjuna, che
è mortale, è di colore bianco (v. Opera al N.).
Nestorianesimo: Movimento
religioso sorto dalle dottrine di Nestorio, teologo siriaco (381-450). In seguito alla
polemica teologica, già maturata nella scuola di Antiochia ad opera di Diodoro di Tarso e
di Teodoro di Mopsuestia, ma fomentata dalle pubbliche asserzioni di Nestorio, ed apertasi
tra quest’ultimo e Cirillo, patriarca di Alessandria, a Roma un sinodo condannò il
N., ed incaricò Cirillo di notificare la condanna a Nestorio (agosto 430). Questi indusse
allora Teodosio II a convocare un concilio ad Efeso (431). Fin dalla prima sessione, sotto
la presidenza di Cirillo, ancora assenti i legati papali e soprattutto i vescovi orientali
filonestoriani capeggiati da Giovanni di Antiochia, Nestorio venne scomunicato e
destituito; pochi giorni dopo i vescovi orientali ritorsero però la condanna su Cirillo.
Dopo un tentativo di compromesso effettuato a Calcedonia, Teodosio sciolse il concilio.
Nel 433 si giunse alla pacificazione tra gli antiocheni e Cirillo, il quale accettò la
formula di unione. La dottrina ortodossa venne fissata con precisione nel corso del
concilio di Calcedonia (451). Accolto ufficialmente nel 486 dalla chiesa persiana, il N.
si diffuse poi nell’Arabia settentrionale, a Ceylon, in India, in Cina ed in Asia
centrale, trovando in queste regioni la sua massima diffusione nel XIII secolo. Dal secolo
successivo cominciò comunque a decadere. Dopo uno scisma (1551), i nestoriani passarono
in parte alla Chiesa di Roma. La chiesa nestoriana conta attualmente circa 200.000 adepti,
soprattutto in Iraq, Iran, Siria e Russia, oltre che in India, nel Caucaso e negli Stati
Uniti.
Nestoriani: Seguaci
della dottrina di Nestorio, teologo siriaco (381-450) (v. Nestorianesimo).
Neter: Nella lingua
geroglifica tre consonanti trascrivono la parola "Dio", NTR, vocalizzato
in neter, nether o netjer. In tale lingua solo lo scheletro consonantico delle
parole è visibile; le vocali rappresentano la carne invisibile, e non vengono scritte.
Quindi oggi ne ignoriamo la fonetica esatta, anche se la si ricostruisce con un
inapprezzabile margine di errore. NTR resta l'unica certezza, e tali consonanti evocano
l'equilibrio delle forze dell'universo, mentre vanno certamente rapportate con il sale natron,
il nitro alchemico, impiegato nei riti di purificazione e di mummificazione. Perciò neter
si può tradurre "quello del sale natron", od anche "quello
che ringiovanisce". L'aggettivo qualificativo netjery corrisponde a divino,
ma anche a ritualizzato, poiché si diventa e si resta N. solo grazie alla potenza
magica del rito.
New Age: Espressione
moderna che significa Nuova Era, l'Era dell'Acquario, la Coscienza del secondo millennio.
Un termine che viene considerato come "un grande fiume nel quale affluiscono fiumi
minori, torrenti e ruscelli. La stagione delle grandi piogge non è ancora iniziata,
quindi il fiume scorre lento. Ma impercettibilmente il livello e la portata delle acque
crescono di giorno in giorno". Si può affermare che lo scrittore tedesco Hermann
Hesse, autore tra l'altro di Siddharta e del Gioco delle perle di vetro,
nonché premio Nobel per la letteratura, sia stato il pratico fondatore di questa moderna
cultura, che coinvolge soprattutto le giovani generazioni di tutto il mondo. La
spiritualità che la N.A. evidenzia nei suoi innumerevoli seguaci si manifesta attraverso
grandi convegni organizzati spesso ed ovunque nel mondo, raduni e congressi che vedono
anche decine di migliaia di partecipanti. La particolare musica N.A., indubbiamente
affascinante e coinvolgente, trova sempre più largo successo, e non solo tra i giovani.
La spiritualità intensa di cui è impregnata la rende ideale per l'impiego in sottofondo
nel corso di sedute di meditazione. I più anziani si distinguono dai giovani solo in
quanto, pur condividendone gli entusiasmi di base, rispettano le Tradizioni classiche che,
mediante la cultura, hanno fatto propria. La N.A. dà comunque ampio spazio ad ogni
cultura esoterica, in cui identifica e riconosce le proprie radici. Induismo, buddhismo,
misticismo, fenomenologia paranormale, medicina alternativa, sciamanesimo, channeling, NDE
ed ufologia sono infatti le principali branche culturali oggetto di particolare attenzione
da parte della N.A., in quanto ognuna di queste implica un'ampia apertura mentale,
caratteristica fondamentale e simbolo della libertà adottate del movimento.
Niaclabut: Parola
alternativa massonica di passo del Grado di Maestro Massone (v. Mac Benat). Ha il
significato di fine, termine, ed è il nome di una montagna dalla quale il re Salomone
faceva estrarre le pietre per la costruzione del Tempio di Gerusalemme. Alcuni studiosi
sono del parere che tale parola di passo sia più esattamente Elabut.
Nicea: Antica città
della Bitinia, corrispondente all’odierna Iznik, posta sulle rive del lago Ascania od
Iznik Gölü. Sono tuttora intatte le mura ed il teatro romano, oltre che i ruderi della
basilica del Concilio e della chiesa della Dormizione, distrutta nella guerra greco turca.
Fu sede di due importanti Concili della Chiesa cristiana. Il primo Concilio fu
convocato dall’imperatore Costantino I (v.) nel 325, per risolvere la questione
ariana ed altri problemi ecclesiali. Intervennero da 220 a 318 vescovi: Ario difese di
persona le proprie dottrine, che furono condannate con l’affermazione della consustanzialità
(dmousia) del Padre e del Figlio, espressa in una
dichiarazione dogmatica (simbolo di N.) che, con le aggiunte del secondo
Concilio di Costantinopoli (381), è tuttora in uso. Nei suoi venti canoni il concilio si
pronunciò anche su questioni dottrinarie minori e su problemi di legislazione e
giurisdizione ecclesiastica. Il secondo Concilio si svolse in otto sessioni,
l’ultima a Costantinopoli (787), con la partecipazione di circa 350 vescovi. Pose
fine alla questione dell’iconoclastia, ammettendo una venerazione onoraria
delle immagini sacre, distinta però dal vero culto riservato a Dio.
Niceno-costantinopolitano: Termine con il quale si identifica il Simbolo del Credo cristiano, la professione
di fede formulata dal concilio di Nicea (v.) del 325, ed adottata dal successivo concilio
di Costantinopoli (v.) del 381 per contrastare l’eresia ariana (v.). Esso diede
particolare risalto alla divinità di Cristo, Figlio di Dio Unigenito, e cioè della
stessa sostanza del Padre, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non
fatto, consustanziale al Padre. Vi si ribadisce il dogma della santissima Trinità, con
l’evidenziazione della Persona dello Spirito Santo. È il Credo recitato durante la
Messa cattolica, e sintetizza tutti i punti essenziali della dottrina cristiana.
Nichilismo: Termine
filosofico indicante ogni dottrina tendente a negare la realtà dell’essere o dei
valori stabiliti. Hamilton parla di un N. metafisico, che nega la realtà sostanziale. È
implicito nelle forme più radicali di fenomenismo, ed ha la sua espressione filosofica
tipica nel Gorgia di Platone. In senso morale e politico invece per N. si intende
la negazione assoluta della norma e del dovere sociale. Al riguardo vale come esempio la
tesi di Stirner, che sostiene che un tale atteggiamento è la conseguenza di una forma di solipsismo
gnoseologico. Nietzsche a sua volta distingue il N. passivo, di chi si rassegna per
debolezza, al conformismo imperante, da quello attivo, che è al servizio della
trasvalutazione dei valori. Infine per Jaspers il N. assoluto è sinonimo della
disperazione. Storicamente il N., come orientamento politico ed ideologico, si diffuse in
Russia nella seconda metà del XIX secolo, dopo l’esito infausto della guerra di
Crimea ed il fallimento delle riforme introdotte da Alessandro II. Profondamente
influenzato dal positivismo occidentale, il N., negando la morale cristiana e la cultura
idealistica, sosteneva la necessità di sopprimere le istituzioni sociali e politiche, e
di ricostruire la società con criteri scientifici. In seguito il termine è stato
erroneamente riferito all’intera ala estremista dell’opposizione allo zarismo,
comprendente anche l’anarchismo rivoluzionario.
Nicodemo: Nome di uno
dei capi dei Giudei di Gerusalemme e membro del Sinedrio (I secolo d.C.), ricordato nel
Vangelo di Giovanni (3, 1-21; 7, 50-53; 19, 39). Difese Gesù contro i Farisei, e portò
mirra ed aloe per imbalsamarne il corpo, insieme con Giuseppe d’Arimatea. A N. venne
attribuito un vangelo apocrifo, suddiviso in parti inizialmente separate: Acta Pilati
(IV secolo) e Descensus Christi ad Inferos (IV-V secolo).
 Nefertari:
Regina egiziana, chiamata anche Nefretere, la grande
sposa reale di Ramses II il Grande (ca. 1290-1224 a.C.), della XIX Dinastia (1309-1194
a.C.). La regina N. è nota soprattutto attraverso la scoperta della sua tomba nella Valle
delle Regine, avvenuta nel 1904 ad opera del grande egittologo ed archeologo Ernesto
Schiaparelli, sostenitore del Museo Egizio di Torino. Questa tomba è fastosamente
arricchita da splendidi affreschi, tutti strettamente legati al "Libro dei Morti",
che aveva la funzione di aiutare il defunto nel corso del suo passaggio al mondo
ultraterreno. N. vi è raffigurata accanto a
numerose divinità, come Iside, Osiride, Horus, Neith, Ra-Haractes, Hathor-Imentit,
Selkis, Nefti, Mut e naturalmente Anubis. Da varie fonti si sa che la sua prematura
dipartita sollevò un’ondata di immenso cordoglio in tutto l’Egitto, e da
manifestazioni pubbliche del sincero dolore del suo sposo. I suoi funerali furono
imponenti, e videro la partecipazione di tutto il complesso clero e della popolazione. Nel
tempio rupestre di Abu Simbel, dedicato alla dea Hathor, tra i sei colossi della facciata
vi sono ben due statue di N., raffigurata con gli attributi della stessa dea Hathor, nella
seconda e nell’ultima statua da sinistra. Nel suo cartiglio N., raffigurata per
rispetto dopo il geroglifico della dea, è scritto che ella è amata da Mut.
Nefertari:
Regina egiziana, chiamata anche Nefretere, la grande
sposa reale di Ramses II il Grande (ca. 1290-1224 a.C.), della XIX Dinastia (1309-1194
a.C.). La regina N. è nota soprattutto attraverso la scoperta della sua tomba nella Valle
delle Regine, avvenuta nel 1904 ad opera del grande egittologo ed archeologo Ernesto
Schiaparelli, sostenitore del Museo Egizio di Torino. Questa tomba è fastosamente
arricchita da splendidi affreschi, tutti strettamente legati al "Libro dei Morti",
che aveva la funzione di aiutare il defunto nel corso del suo passaggio al mondo
ultraterreno. N. vi è raffigurata accanto a
numerose divinità, come Iside, Osiride, Horus, Neith, Ra-Haractes, Hathor-Imentit,
Selkis, Nefti, Mut e naturalmente Anubis. Da varie fonti si sa che la sua prematura
dipartita sollevò un’ondata di immenso cordoglio in tutto l’Egitto, e da
manifestazioni pubbliche del sincero dolore del suo sposo. I suoi funerali furono
imponenti, e videro la partecipazione di tutto il complesso clero e della popolazione. Nel
tempio rupestre di Abu Simbel, dedicato alla dea Hathor, tra i sei colossi della facciata
vi sono ben due statue di N., raffigurata con gli attributi della stessa dea Hathor, nella
seconda e nell’ultima statua da sinistra. Nel suo cartiglio N., raffigurata per
rispetto dopo il geroglifico della dea, è scritto che ella è amata da Mut.