Angelus: Denominazione della
preghiera recitata dal popolo cattolico la mattina, a mezzogiorno ed alla sera, in onore
della Santa Vergine Maria.
Anglicanesimo: Insieme
delle dottrine e dell’organizzazione della Chiesa d’Inghilterra, sorta dopo il
distacco da Roma e sotto l’influenza della Riforma protestante. La Chiesa anglicana
fu costituita nel 1534, quando Enrico VIII fece approvare dal parlamento l’Atto di
supremazia, con il quale si sostituiva al papa nel governo della Chiesa, rompendo così i
rapporti dei fedeli inglesi con la Santa Sede. Sotto Edoardo VI ed Elisabetta I furono
accolti parecchi elementi della teologia e della pratica protestanti di stampo calvinista
(matrimonio per i religiosi, comunione sotto le due specie, liturgia in lingua volgare), e
fu definita la liturgia (Libro di preghiere del 1549); la proclamazione dei 39
articoli di religione (1563) completò l’opera di sistematizzazione. Nel XVIII
secolo, sotto il regno della regina Anna, venne confermata la completa sottomissione della
Chiesa alla corona (Atto di uniformità, 1713; Atto dello scisma, 1714). Non
mancarono tentativi di resistenza: alla fine del XVIII secolo, la predicazione di Law e
dei fratelli Wesley dette luogo al metodismo, mentre il partito evangelico, costituendo la
cosiddetta Chiesa bassa (Low Church) intendeva valorizzare la
tradizione calvinista. Nel XIX secolo la reazione alla completa sottomissione della Chiesa
alla corona provocò invece il recupero di molti elementi del cattolicesimo, a cui
contribuì principalmente il movimento di Oxford, con la costituzione entro la Chiesa
anglicana di un partito anglocattolico (v.), detto della Chiesa alta (High
Church).
Anglocattolicesimo: Movimento
spirituale sviluppatosi nel XIX secolo nel seno della Chiesa anglicana (v. anglicanesimo),
con l’intento di favorire una riapertura verso il cattolicesimo romano, mediante un
sistematico riavvicinamento in campo dottrinale e liturgico. Nato dal Movimento di Oxford
(1833), che ebbe i suoi maggiori esponenti in John Henry Newman (1801-1890), il poeta John
Keble (1792-1866) ed Edward Bouverie Pusey (1800-1882), che facevano parte della Chiesa
alta (v. Anglicanesimo), ed intendevano reagire alla secolarizzzione della Chiesa. Newman
passò al cattolicesimo (1845), mentre Pusey e Keble rimasero nella Chiesa anglicana,
dando origine all’A. che, sia in campo dottrinale (problema della Grazia, comunione
dei santi, istituzione e struttura della Chiesa), sia in campo liturgico (celebrazione
della Messa, conservazione delle specie liturgiche, servizio divino secondo la liturgia
tradizionale) segnò un notevole concreto avvicinamento alla Chiesa cattolica. L’A.
subì una grave crisi alla fine del XIX secolo, quando Leone XIII sancì
l’invalidità delle ordinazioni anglicane; ma si riprese grazie alla guida di
illustri personaggi, fra i quali Lord Halifax e Thomas Eliot.
Anima del mondo: Concetto
che deriva dalla teologia orientale e dall’antico pitagorismo (v.). Lo si trova
successivamente in Platone (v.), che nel Timeo ne diede la prima sintesi
speculativa: la divinità, secondo la cosmogonia platonica, ha costruito il mondo corporeo
o fisico, e vi ha posto al centro l’anima (o spirito), la quale nell’universo,
vivente come tutto, svolge la funzione di forza immateriale dispensatrice di vita e di
movimento alla materia. La presenza della materia nell’A. del mondo permetterebbe la
riproduzione delle infinite forme della realtà sensibile. Il concetto, tralasciato da
Aristotele (v.), ricomparve con gli Stoici (v.), che parlano di un pneuma (v.), o
fuoco artefice, infiammato e pensante, che penetra il mondo e fa tutt’uno con Dio, e
quindi diviene una forma divina insita nella natura. Nel neoplatonismo (v.) di Plotino
(v.), l’A. del mondo ha funzione di mediazione tra l’intelligibile ed il
sensibile, ed è il principio da cui derivano le anime (o spiriti) individuali. Con il
cristianesimo il concetto venne abbandonato: nel Medioevo, con la ripresa degli studi
platonici, fu avvicinato allo Spirito Santo, ma esso riassunse vigore soprattutto nel
Rinascimento, nel senso di principio attivo della natura (v. Paracelso e Giordano Bruno).
In epoca moderna ne parla Schelling, come continuità tra mondo organico ed inorganico.
Anima: Termine che in molte filosofie e dottrine religiose viene sistematicamente confuso con lo Spirito, assumendone i significati. Per la comprensione effettiva del reale significato dell'A. occorre esaminare a fondo l'elemento naturale più evoluto che la contiene, ovvero l'Uomo. Che cos’é l'essere umano? Per rispondere al meglio al quesito, è opportuno far riferimento al principio ermetico, secondo il quale il microcosmo si identifica nel macrocosmo, per cui il piccolo è identico al grande. Fin dall'antichità greca classica, in particolare da Pitagora e Platone in poi, viene riconosciuta l'esistenza di una realtà superiore, popolata di energie invisibili, presente oltre la natura visibile e sensibile. L'universo era stato fin da allora suddiviso in una terna di diverse manifestazioni, comprendenti un piano materiale, un piano psichico ed un piano spirituale, secondo una peculiare gerarchia rimasta inalterata per millenni, fino al tardo medioevo. A ciascun piano corrisponde un peculiare aspetto, ovvero un diverso stato: 1) stato di non
manifestazione, rappresentante la Possibilità Universale; 2) stato di
manifestazione informale, o sottile, rappresentante l'A. del Mondo; 3) stato di
manifestazione formale, o grossolano, ovvero quello del mondo della sostanza del corpo
fisico. L'uomo era collocato al centro del "cosmo", data l'identità
degli elementi componenti entrambi. In analogia all'armonia caratteristica del cosmo e
dell'uomo, anche a quest'ultimo furono assegnate tre forme esistenziali: al mondo
materiale corrispose il corpo fisico, al mondo psichico l'A., al mondo
eterico lo spirito (v.). Da ciascuna natura (o mondo o piano) nacque una disciplina
di studio: rispettivamente fisica, psicologica e metafisica. Tale ripartizione era
caratteristica di ogni dottrina tradizionale, anche se ciascuna dottrina si differenziava
nell’ampiezza dei confini di ciascun piano. Presente nelle tradizioni asiatiche,
caratterizza anche quella ebraica, come dimostrato dall'inizio della Genesi, dove l'A.
vivente è raffigurata come unione del corpo con il soffio dello spirito. Questa
ripartizione ternaria fu adottata da Platone, e le correnti filosofiche latine
neoplatoniche tradussero i termini greci nous (nous), psyche (psiché) e soma
(soma), con gli equivalenti Spiritus, A. e Corpus. La tradizione cristiana ereditò la
ripartizione, come riportato all'inizio del Vangelo di Giovanni, fondamento
dell'esoterismo occidentale, ove la terna Verbum, Lux et Vita corrisponde ai tre
mondi citati: spirituale, psichico e fisico (o corporale). San Paolo, nella sua
prima lettera indirizzata ai Tessalonicesi, dice testualmente: " E lo stesso Dio
custodisca tutta la vostra persona, spirito, A. e corpo, senza macchia". Sant'Ireneo,
nel De Resurrectione, ancor più chiaramente sostiene: " Esistono tre
principi dell'uomo: corpo, A. e spirito. Quello che salva e forma é lo spirito.
Quello che è unito e formato è il corpo. L'intermediario tra i due è l'A. Quest'ultima
a volte segue lo spirito, e da questo viene elevata. A volte invece discende fino al
corpo, sottostando agli appetiti terreni". Fu proprio per evitare il rischio
pernicioso di attribuire all'A. elementi troppo corporali, come infatti fece Platone, che
i dottori della Chiesa cristiana preferirono avvicinare l'A. allo spirito, fino ad
arrivare a confonderli tra loro, dando origine al più semplificato dualismo corpo
e A. Da questo abbinamento nasce la persistente confusione tra psichico e spirituale, tra
cui oggi, almeno per i più, continua a non esserci differenza alcuna. Rimane tuttavia il
fatto che, se l'A. è la mediatrice, l'elemento catalizzatore tra il superiore e
l'inferiore della natura umana, è indispensabile che tra loro esista un collegamento
naturale. Per cui sia Sant'Agostino che San Bonaventura definiscono col termine
"A." il corpo sottile, mediano tra corpo fisico e spirito. Opportuno accennare
come l'analisi del corpo fisico, effettuata seguendo i principi della filosofia teosofica
(v.), fondamento di dottrine, religioni e credenze passate e future, permetta di arrivare,
attraverso un lungo e complesso processo, ad una classificazione. Tramite questa diventa
possibile la spiegazione dei fenomeni della vita e della stessa coscienza. Lo spirito
umano dispone di strumenti ed arnesi, indispensabili per realizzare l'evoluzione, ovvero
il completamento conoscitivo della coscienza. Si tratta di veicoli veri e propri, qui
riportati con la loro corrispondenza in sanscrito, ovvero:
1) Corpo, o veicolo rozzo;
2)
Vitalità, o Prana;
3) Corpo astrale, o Linga Sarira;
4) Anima animale, o Kama
Rupa;
5) Anima umana, o Manas;
6) Anima spirituale, o Buddhi. Aggiungendo
a questi veicoli il
7) Corpo etereo, o Atman,
otteniamo la tipica ripartizione settenaria
dell'essere umano, adottata da tutte le dottrine orientali, che implicano comunque
l'assoggettamento delle creature alle leggi della "metempsicosi" (v.),
per cui lo spirito deve successivamente transitare, dimorandovi, nei mondi minerale,
vegetale, animale ed umano. In occidente invece s'è continuato a considerare la
ripartizione ternaria, più che altro per evidenti ragioni teologiche, se non addirittura,
come abbiamo visto, la sua comoda ma errata semplificazione dualistica, tuttora vigente.
L'approfondimento della ricerca nel campo della realtà invisibile, avviato proprio in
occidente all'inizio del secolo scorso, ha implicato un ritorno alle origini dell'era
cristiana, con l'adozione di definizioni più sofisticate, accurate e comprensibili delle
"tre" diverse nature, sia universali o cosmiche che umane: 1) Corpo - Corpo
fisico - Materia sensibile; 2) A. - Corpo astrale - Mondo astrale; 3) Spirito -
Corpo etereo - Mondo mentale, spirituale od etereo (v. Astrale).
Animismo: (G.O.I.) Costituisce
la credenza di svariati popoli, per cui ogni cosa od aspetto dell'universo, dai minerali
ai grandi fenomeni naturali, possiede un'anima ed uno spirito che ne dirige l'esistenza e
la funzione. Non ha mai costituito una vera religione, ovvero una credenza in grado di
legare una qualsiasi comunità umana, perché il culto tributato ai vari spiriti ha sempre
conservato una fisionomia individuale ed accessoria, fatta forse eccezione per il manismo, o culto degli animali. Fulcro dell'A. è anche la ripartizione degli spiriti in benigni ed ostili, i primi da onorare per invocarne l'aiuto, i secondi da propiziare con appositi sacrifici onde evitarne la malevolenza. L'A. è ancora ben presente tra le popolazioni dell'Africa centrale, specie tra gli agricoltori, e più diffusamente nel corno d'Africa. È anche praticato in Oceania, ove peraltro assume caratteristiche prossime al manismo, nonché in vaste comunità indigene dell'America meridionale. L'A. è spesso frammisto a forme primitive di religiosità feticistiche, che fanno oggetto di culto pietre confinarie, armi, conchiglie, pezzi di legno, meteoriti, ossa, pellami e statuette (totem), mentre in epoche più recenti sono oggetto di venerazione orologi, vetture, aeroplani o parti di essi. I feticci più comuni sono comunque costituiti da contenitori (vasi, corni o teschi) e da materiali naturali in cui si ritiene risieda lo spirito, come argilla, radici, ecc. Sono seguaci delle varie forme di A. circa 50 milioni di individui.
 Ankh: Termine egiziano antico designante la croce ansata, il simbolo della vita come nodo che scioglie la morte. A. è l’esatto contrario della morte, in quanto rappresenta la vita per l’eternità, una linea verticale che ne incrocia una orizzontale (v. Croce) con, nel punto d’incontro, l’inizio di un nuovo ciclo: una vita riattivata. Identifica quindi il passato, il presente ed il futuro: ieri, oggi e domani. È l’eternità tra le mani dell’uomo, davanti alle sue mani ed alle sue narici. Significa anche aprire la strada al soffio, e lasciar scorrere l’acqua liberamente, nutrendo il grande corpo della Terra. Al centro un chicco di grano: dopo la sua putrefazione esso sta finalmente per germogliare, è vivo.
Ankh: Termine egiziano antico designante la croce ansata, il simbolo della vita come nodo che scioglie la morte. A. è l’esatto contrario della morte, in quanto rappresenta la vita per l’eternità, una linea verticale che ne incrocia una orizzontale (v. Croce) con, nel punto d’incontro, l’inizio di un nuovo ciclo: una vita riattivata. Identifica quindi il passato, il presente ed il futuro: ieri, oggi e domani. È l’eternità tra le mani dell’uomo, davanti alle sue mani ed alle sue narici. Significa anche aprire la strada al soffio, e lasciar scorrere l’acqua liberamente, nutrendo il grande corpo della Terra. Al centro un chicco di grano: dopo la sua putrefazione esso sta finalmente per germogliare, è vivo.
Anno
(Grande di Platone): Denominazione dell’anno che cade
ogni 25.920 anni solari, suddiviso in 12 cicli (come lo Zodiaco, v.) di 2.160 anni.
Ciascun ciclo è costituito dal periodo di tempo in cui gli equinozi avvengono sotto uno
stesso segno, per cui ogni ciclo è soggetto all’influenza astrale di una
costellazione, ovvero di un segno zodiacale, e corrisponde ad un’Era. Nel corso del
ciclo del Toro, ovvero nell’Era del Toro, le religioni ebbero come simbolo questo
animale (bue Apis, Toro alato, Minotauro, ecc.); all’Era del Toro successe quella
dell’Ariete, allorché Mosé discese dal monte Sinai per annunciare la fine del tempo
del Toro e l’inizio dell’Era dell’immolazione dell’agnello. La venuta
di Cristo coincide con i primi anni dell’Era dei Pesci, il cui simbolo venne adottato
dai primi cristiani. Tale ciclo è terminato nel 1948, quando ha avuto inizio
l’attuale Era dell’Acquario (v.).
Anno
Esoterico:
Denominato
anche magico, rispecchia le antiche festività del calendario Celtico. Esso
rappresenta e costituisce un vero cammino spirituale, composto di varie tappe
evolutive o maturative. Secondo il moderno Esoterismo, si ricollega alle antiche
scuole pitagoriche, e parte da bisogni concreti, quotidiani, per spingere
gradualmente attraverso un processo di purificazione (spirituale e materiale)
verso il trascendente e la maggiore consapevolezza di sé stessi. L'A. è in
piena armonia con i cicli stagionali, e comprende otto Festival celebrati
ritualmente in corrispondenza degli Equinozi e dei Solstizi, nonché alla metà
d'ogni stagione. L'A. inizia il 31 ottobre con ¨
1:
«Samhain», nota come Halloween
(v.), od Ognissanti, il giorno della
discesa della scintilla divina che, come seme interrato, germoglia per dare
inizio alla nuova vita. A questo seguono: ¨
2:
«Yula», il 21 dicembre, i Saturnali,
il Solstizio, la festa di mezzo Inverno, il culmine dell'azione purificatrice;
¨
3:
«Imbolc, o Candlemas», il 2
febbraio, la Candelora (v.), l'inizio della Primavera e del vero cammino
spirituale; ¨
4:
«Eostara, Lady Day», il 21 marzo,
l'Equinox, la festa di mezza
Primavera;
5:
«Beltane, o May Day», il 30 aprile,
il Calendimaggio, inizio dell'Estate, si gettano le basi di una condizione più
elevata;
6:
«San Giovanni», il 24 giugno,
Solstizio e festa di mezza Estate, in cui l'avvenuta introspezione porterà ad
una maggiore sensibilità, cui consegue il potere esoterico.
7:
«Lugnasad, o Lammas», il 31 luglio,
avvio del raccolto, anche in senso spirituale, ed inizio dell'Autunno,
affrancamento dal dolore e disposizione verso l'infinito.
8:
«San Michele» detto Superno, il 29
settembre, Equinozio, festa di mezzo Autunno, avvio dell'autoanalisi ed
acquisizione della consapevolezza.
Sinteticamente,
si tratta della progressiva purificazione dell'inconscio, nonché del
risveglio dei poteri latenti, contemplati da ogni scuola esoterica. Per cui il
sistema energetico del Kundalini-Yoga (v.) è analogo al Caduceo (v.) di Ermete (v.) ed all'Albero Sefirotico della Vita (v.) della Qabbalah (v.). Le succitate
otto tappe maturative del calendario Celtico non sono che livelli di sviluppo
della consapevolezza (v.), come le serpi Ida
e Pingala nel Sushumma, che
risalgono lungo la catena dei Chakra
(v.), o la Via del Pilastro di Mezzo, che unisce la Sephira inferiore (il Serpente, v. Uroboros) a quella superiore (l'Aquila) lungo l'Albero della
Vita.
Anno liturgico: Serie delle feste e dei tempi festivi della Chiesa. È misurato in 52 settimane suddivise in tre grandi cicli: natalizio, pasquale e della pentecoste. L’A. inizia con la prima delle quattro domeniche dell’Avvento (sei nel rito Ambrosiano) precedenti il Natale,
la cui data è fissata al 25 dicembre. La data della Pasqua è variabile, perché
stabilita nella prima domenica successiva al plenilunio di marzo; essa è preceduta dalla
Quaresima, che ha valore preparatorio e penitenziale, ed è seguita dal ciclo pasquale che
si conclude con la festa della Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua. Segue un ciclo di 24
settimane, detto "tempo dopo la Pentecoste", che termina con la prima
domenica dell’Avvento successivo.
Anno massonico: Ai fini della datazione valida per tutti i Riti Simbolici della Libera Muratoria, occorre considerare che Marzo é il primo mese dell’anno, e quindi Febbraio é l’ultimo, proprio in accordo con le cadenze dello Zodiaco. Infatti al mese di Marzo corrisponde il primo segno dell’Ariete, mentre a Febbraio cade l’ultimo, ovvero quello dei Pesci (v. Calendario massonico). Nei riti Scozzesi invece l’A. ha inizio in settembre e termina in agosto. Amministrativamente e gestionalmente invece, l’A. è sempre iniziato in settembre, per terminare con la festa di San Giovanni d’Estate (24 giugno). Così continua ad essere in tutte le obbedienze massoniche del mondo, fuorché in Italia, dove a partire dal 1983 il G.O.I. ha deliberato la coincidenza dell’A. con l’anno calendariale normale: inizia quindi il 1° gennaio per terminare il 31 dicembre.
Anno sabbatico: Presso gli Ebrei era così definito l’anno dedicato al riposo della Terra, perché ricalcante il riposo del signore al termine della creazione (v. Sabaoth). Aveva inizio al termine dei raccolti, tra metà settembre e metà ottobre, e ricorreva ogni sette anni, seguendo una disposizione del Levitico:
Anno Santo: La Chiesa cattolica proclama santo l’anno in cui i fedeli possono beneficiare di particolari benedizioni ed indulgenze, essendovi solennemente invitati alla conversione. Le radici di questo complesso rituale vanno ricercate nell’antica usanza ebraica del giubileo
(v.). Il primo A. venne celebrato all’inizio del XIV secolo, conseguenza di un moto
popolare spontaneo provocato dalle correnti penitenziali che pullulavano in Italia a
partire dal 1260. La sera del primo giorno dell’anno 1300 una folla strabocchevole si
riversò nella basilica di San Pietro in Roma per richiedere un’indulgenza
straordinaria. Il 22 febbraio successivo papa Bonifacio VIII dispose con un’apposita
bolla che chiunque avesse fatto visita alla basilica dell’apostolo Pietro dopo
essersi pentito ed aver confessato i propri peccati, avrebbe ottenuto la totale remissione
delle pene del Purgatorio. Egli stabilì inoltre che che tale evento si celebrasse ogni
secolo. Successivamente Paolo II (1464-71) ridusse tale periodo a 25 anni, onde permettere
ad ogni generazione di beneficiarne. In particolari circostanze il papa può indire un A.
straordinario, come fecero Pio XI nel 1933 (per celebrare i 1900 anni della morte e
resurrezione di cristo) e Giovanni Paolo II nel 1983. Oltre alla confessione sacramentale
ed alla comunione eucaristica, per godere dell’indulgenza connessa all’A. è
necessario visitare le quattro basiliche romane. Ormai saldamente inserita nel calendario
ufficiale della Chiesa cattolica, questa scadenza intreccia molteplici motivi: dal gesto
per impetrare il perdono dei peccati, al valore devozionale del pellegrinaggio, al
riconoscimento della centralità della sede romana per la memoria della cattedra di San
Pietro e per il ruolo del suo successore. Particolare solennità riveste la celebrazione
dell’A. 2000, che viene proposta a tutta la cristianità, alle soglie del suo terzo
millennio.
Anno: Unità di misura temporale, corrispondente al periodo di una rivoluzione della terra intorno al sole, che ha la durata complessiva di 365 giorni, 6 ore, 9 minuti primi e 9 minuti secondi, denominato A. sidereo od astrale. Per effetto della precessione degli
equinozi, esso risulta abbreviato a 365 giorni, 5 ore, 48 minuti primi e 46 minuti
secondi. L’avvicendamento delle stagioni ed il sentimento della circolarità del
tempo, anzi dell’eterno ritorno di focali situazioni cosmologiche e stagionali
(M. Eliade), furono costantemente presenti all’uomo tradizionale. Ecco perché il
periodico ritorno di un astro o di una costellazione, come ogni transito stagionale, sono
sempre stati salutati con particolare solennità, presso le comunità arcaiche o
premoderne in genere. Si riteneva che in ciascuno di essi si rivelasse un momento
privilegiato, in cui era possibile rigenerare l’intero universo grazie ad appositi
riti, riproducenti il districarsi primigenio del caos, il suo farsi cosmo, ovvero ordine
ed armonia. Equinozi e solstizi, vennero perciò intesi come momenti favorevoli per
cacciare demoni, malattie e peccati. Ne danno testimonianza tanto gli antichi rituali
babilonesi come le attuali tradizioni popolari, più o meno deformate rispetto
all’antico, sparse in tutto il globo. Questo trova eloquente illustrazione nei riti
di capodanno (v.). Un caso particolare è rappresentato dall’A. sabbatico
(v.), lungo il cui corso veniva sospesa la lavorazione della terra da parte degli Ebrei,
secondo quanto stabilito dalla Legge (Levitico XXV, Deuteronomio XV), per commemorare il
riposo del Signore al settimo giorno della Creazione, e per lasciare riposare la stessa
terra. In quell’A. i prodotti spontanei erano assegnati ai poveri, e sussisteva
l’obbligo di condonare i debiti. In Luca (4, 19) Gesù designa la sua venuta come
compimento dell’A. sabbatico.
Ansia: (G.O.I.) Tutti
sappiamo cosa significa essere ansiosi, ma quando cerchiamo di definire l'A. constatiamo
che ogni possibile definizione è del tutto inadeguata. Anche l'accostamento dell'A. alla
paura non convince pienamente, in quanto la paura appare legata a fatti specifici, mentre
l'A. è decisamente più generica. Superficialmente l'A. sembrerebbe legata alle
incertezze del futuro, ma una breve riflessione evidenza che essa rappresenti piuttosto
una specie di "immanenza" che si accompagna al nostro presente. Le radici
dell'A. sono alimentate da un passato o da un presente, assai difficile da cogliere.
Nell'A. si percepiscono forze di natura malevola e assai poco luminosa che operano come
filtri, che oscurano e distorcono profondamente la nostra libera percezione delle
ispirazioni. Tuttavia, ad una più attenta osservazione, può apparire la profonda
differenza fra le forze che fanno parte dell'immanenza e la forma, il più delle volte del
tutto inconsistente e soggettivamente arbitraria, con la quale esse sembrano manifestarsi
a noi. Per tali motivi l'A. dovrebbe essere considerata come la più grande mistificatrice
presente nella vita.
Antichi Doveri:
Alle Costituzioni massoniche del 1723 sono annessi gli Old
Charges, ovvero gli Antichi Doveri. Questi rivestono particolare importanza per la
Massoneria Universale, poiché non si presentano in termini esclusivamente normativi, in
quanto sono circonfusi di una vetusta autorevolezza che ne sancisce il valore di principi
anziché di norme. Essi esordiscono con un paragrafo (Concernente Dio e la Religione) che
ha fatto e continua a far discutere gli esperti di cose massoniche: "Un Muratore
è tenuto, per la sua condizione, ad obbedire alla legge morale; e se egli intende
rettamente l’Arte, non sarà mai un ateo stupido né un libertino irreligioso. Ma
sebbene nei tempi antichi i Muratori fossero obbligati in ogni Paese ad essere della
Religione di tale Paese o Nazione, quale essa fosse, oggi peraltro si reputa più
conveniente l’obbligarli soltanto a quella Religione nella quale tutti gli uomini
convengono, lasciando ad essi le loro particolari opinioni: ossia essere uomini liberi e
sinceri, o uomini d’onore e d’onestà, quali che siano le denominazioni o le
convinzioni che li possono distinguere; per cui la Massoneria diviene il Centro di Unione
ed il mezzo per conciliare sincera amicizia tra persone che sarebbero rimaste
perpetuamente distanti". Secondo il Moramarco (Nuova Enciclopedia Massonica),
si tratta di un passo estremamente latitudinario, che pone a fondamento dell’iter
muratorio alcune qualificazioni etiche aspecifiche, ovvero che dovrebbero essere proprie
di qualsiasi associazione filantropica. Inoltre vi si parla di ateo stupido, e non
di ateo in generale, il che ha consentito alle Massonerie irregolari che ammettono
in loggia gli atei dichiarati di sottilizzare sulla grande rilevanza che avrebbe
l’aggettivo stupido. Si ipotizza insomma, forse con una forzatura indecente,
che l’estensore di questo charge avrebbe inteso negare la qualifica massonica
solo agli atei superficiali e non a quelli pensanti o problematici. Indubbiamente il vizio
del passo è quello di aver eccessivamente diluito la sostanza di cui è costituita la
spiritualità massonica, riducendola a commendevoli ma generiche prerogative etiche.
D’altro canto è pure vero che solo una lettura non contestuale può contrabbandare
il titolo generale in questione, come neutrale rispetto al problema della fede nel grande
Architetto dell’Universo; un’occhiata panoramica alla produzione letteraria
massonica dell’epoca è sufficiente per rendersi conto di come tale fede sottendesse
implicitamente l’intero impianto muratorio. La formulazione di un principio
latitudinario (implicitamente teista ma apparentemente relegato nell’ambito
dell’etica) come quello del primo tra gli Antichi Doveri, si giustifica pienamente se
si considera che essa valse come correttivo speculare di una tradizione, secondo la quale
il primo dovere dei Muratori era quello di essere leali a Dio ed alla santa chiesa,
rifiutando le eresie ed identificando così la fede con una religione specifica. Dal
momento che la Massoneria si proponeva come Universale, nell’evidente consapevolezza
che l’arte muratoria ebbe ed ha valenze sacrali anche fuori dall’alveo culturale
del cristianesimo, era del tutto logico che proponesse come minimo qualificativo dei suoi
membri quella religione universale che, sul fondamento dell’origine divina
dell’universo, stabilisce alcuni principi accettabili da tutte le tradizioni
religiose. Forse il vizio del primo antico Dovere sta nel fatto di aver evidenziato più
le conseguenze etiche che il fondamento religioso della Libera Muratoria. Così pare
pensarla uno studioso massone contemporaneo, l’americano John Nocas, membro della
Società dei Filaleti (v.), che in un saggio del 1984 sostiene che la formulazione in
questione contribuì: · all’inquietudine
nell’ordine, per ragioni di lesa identità; ·
all’avversione cattolica per la Massoneria; · alla
formazione di corpi massonici cristiani (di tipo templare, cavalleresco, rosacrociano,
ecc.) reattivi alla de-cristianizzazione, la quale fu pure un processo lungo e laborioso,
che si poté dire definito solo nel 1813, con l’Atto d’Unione delle Grandi Logge
dei Moderns e degli Ancients. Gli A. stabiliscono poi le linee generali del
rapporto che deve intercorrere tra la Massoneria e la società civile, nei seguenti
termini: "…Un Muratore è un pacifico suddito dei Poteri Civili, ovunque egli
risieda o lavori, e non dev’essere mai coinvolto in complotti contro la pace ed il
benessere della Nazione (…); poiché la Muratoria è sempre stata danneggiata da
guerre, massacri e disordini; così gli antichi Re e Principi furono assai disposti ad
incoraggiare gli uomini 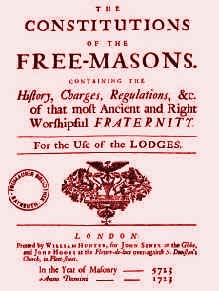 dell’Arte, a causa della loro tranquillità e
lealtà; per cui essi praticamente risposero ai cavilli dei loro avversari e promossero
l’onore della Fraternità, che sempre fiorì nei tempi di pace. Cosicchè se un
fratello divenisse un ribelle contro lo Stato, egli non deve essere favorito nella sua
ribellione, ma piuttosto compianto come uomo infelice …". Questo secondo
dovere (Del Magistrato Civile Supremo e Subordinato) è la codificazione del lealismo
massonico. Esso impegna l’Istituzione a mantenersi estraneo alla mischia politica, ed
a prestare obbedienza al governo civile. Come il primo, anche questo dovere riflette,
ancora una volta con una significativa variante, una norma reperibile presso i Massoni
operativi. Costoro infatti erano tenuti ad essere leali al re, "senza tradimento o
falsità", e ad emendare eventuali congiure di cui fossero a conoscenza, o ad
avvertire altrimenti "il sovrano od il suo consiglio". Qui troviamo
invece che l’eventuale ribelle dev’essere scoraggiato e compianto, ma non
necessariamente denunciato all’autorità od espulso dalla comunione massonica, anzi
il charge in oggetto recita: "sebbene la leale Fratellanza possa e debba
sconfessare la sua ribellione, e non dare ombra o base per la gelosia politica del governo
in essere, egli non può essere espulso dalla loggia, ed il suo vincolo rimane
irrevocabile". In sintesi, la Massoneria moderna si presenta con i tratti del
lealismo istituzionale nel rispetto delle clausole di coscienza, vale a dire dei diritti
individuali: un suo membro si assume piena ed esclusiva responsabilità per le proprie
azioni, e non può essere espulso dall’Ordine per motivi politici. L’ablazione
della catena fraterna può bensì aver luogo per motivi di indegnità o comunque per altri
"delitti", come soggiunge allusivamente lo stesso charge, e come
più dichiaratamente esplicitano le normative dei vari corpi massonici allorché, ad
esempio, similmente alle Costituzioni del Grande Oriente d’Italia, definiscono come
colpa massonica "ogni azione contraria alla lealtà, all’onore od alla
dignità della persona umana". Concretamente, l’atteggiamento della
Massoneria moderna rispetto all’eventualità di serpeggiamenti cospiratori al suo
interno, è di attenta vigilanza, affinché le velleità individuali d’ogni segno non
coinvolgano o non compromettano la neutralità dell’Istituzione, ragion per cui la
tendenza è quella di stroncarle preventivamente. Si pensi ai provvedimenti adottati da
Armando Corona, Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, per impedire la formazione
o la riformazione di organismi paralleli ed incontrollabili all’interno
dell’Obbedienza da lui presieduta (v. P2). Gli A. proseguono poi con la definizione
della Loggia ("Una Loggia è un luogo dove i Muratori si raccolgono ed operano
(…) ed ogni Fratello deve appartenere ad una, ed essere soggetto alle sue norme ed ai
regolamenti generali") e delle
dell’Arte, a causa della loro tranquillità e
lealtà; per cui essi praticamente risposero ai cavilli dei loro avversari e promossero
l’onore della Fraternità, che sempre fiorì nei tempi di pace. Cosicchè se un
fratello divenisse un ribelle contro lo Stato, egli non deve essere favorito nella sua
ribellione, ma piuttosto compianto come uomo infelice …". Questo secondo
dovere (Del Magistrato Civile Supremo e Subordinato) è la codificazione del lealismo
massonico. Esso impegna l’Istituzione a mantenersi estraneo alla mischia politica, ed
a prestare obbedienza al governo civile. Come il primo, anche questo dovere riflette,
ancora una volta con una significativa variante, una norma reperibile presso i Massoni
operativi. Costoro infatti erano tenuti ad essere leali al re, "senza tradimento o
falsità", e ad emendare eventuali congiure di cui fossero a conoscenza, o ad
avvertire altrimenti "il sovrano od il suo consiglio". Qui troviamo
invece che l’eventuale ribelle dev’essere scoraggiato e compianto, ma non
necessariamente denunciato all’autorità od espulso dalla comunione massonica, anzi
il charge in oggetto recita: "sebbene la leale Fratellanza possa e debba
sconfessare la sua ribellione, e non dare ombra o base per la gelosia politica del governo
in essere, egli non può essere espulso dalla loggia, ed il suo vincolo rimane
irrevocabile". In sintesi, la Massoneria moderna si presenta con i tratti del
lealismo istituzionale nel rispetto delle clausole di coscienza, vale a dire dei diritti
individuali: un suo membro si assume piena ed esclusiva responsabilità per le proprie
azioni, e non può essere espulso dall’Ordine per motivi politici. L’ablazione
della catena fraterna può bensì aver luogo per motivi di indegnità o comunque per altri
"delitti", come soggiunge allusivamente lo stesso charge, e come
più dichiaratamente esplicitano le normative dei vari corpi massonici allorché, ad
esempio, similmente alle Costituzioni del Grande Oriente d’Italia, definiscono come
colpa massonica "ogni azione contraria alla lealtà, all’onore od alla
dignità della persona umana". Concretamente, l’atteggiamento della
Massoneria moderna rispetto all’eventualità di serpeggiamenti cospiratori al suo
interno, è di attenta vigilanza, affinché le velleità individuali d’ogni segno non
coinvolgano o non compromettano la neutralità dell’Istituzione, ragion per cui la
tendenza è quella di stroncarle preventivamente. Si pensi ai provvedimenti adottati da
Armando Corona, Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, per impedire la formazione
o la riformazione di organismi paralleli ed incontrollabili all’interno
dell’Obbedienza da lui presieduta (v. P2). Gli A. proseguono poi con la definizione
della Loggia ("Una Loggia è un luogo dove i Muratori si raccolgono ed operano
(…) ed ogni Fratello deve appartenere ad una, ed essere soggetto alle sue norme ed ai
regolamenti generali") e delle 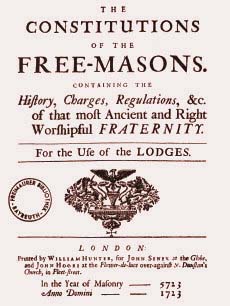 condizioni di ammissibilità di un profano in Loggia. Qui i
Doveri accorpano nelle clausole di iniziabilità fattori spiritualmente significativi con
altri forse dettati dallo spirito dei tempi, e come tali rappresentano, secondo alcuni
studiosi di massoneria, probabili ostacoli all’espansione di coscienza suggerita
nella via iniziatica. Si tratta del passo secondo il quale i candidati devono esser
"non schiavi, non donne, non uomini immorali e scandalosi, ma di buona
reputazione". Evidentemente l’interdizione dell’accesso in Loggia agli
schiavi rappresentava un tributo alla realtà dell’epoca, in essenza certo non
attuale; l’esclusione delle donne aveva la duplice valenza tradizionale ed iniziatica
(v. Massoneria e Donna). Infine l’ultima preclusione era di tono squisitamente
morale. Qualche perplessità nasce dalla considerazione che tre diverse motivazioni tanto
eterogenee siano state sbrigativamente condensate in un unico charge e così
omologate, poiché esse rivestono importanza diversificata, mentre sono sicuramente
foriere di profonde implicazioni. Gli A. si diffondono poi sulla deontologia massonica
dentro e fuori la Loggia, mutuando cospicui elementi dalla tradizione operativa: vi si
raccomandano la prudenza nella trattazione dei segreti del mestiere, l’armonia tra i
membri dell’Arte, la sobrietà di condotta nei divertimenti e la temperanza nei
convivii, la pacifica soluzione "intra moenia" delle eventuali
controversie tra i Muratori. Nella conclusione si invitano i Fratelli all’Amore
fraterno, già definito "la pietra di fondazione e di volta, il cemento e la
gloria di questa antica Fratellanza", affinché "tutti possano vedere la
benefica influenza della Muratoria, come tutti i veri Muratori hanno fatto dal principio
del mondo, e faranno fino alla fine dei tempi. Amen, così sia".
condizioni di ammissibilità di un profano in Loggia. Qui i
Doveri accorpano nelle clausole di iniziabilità fattori spiritualmente significativi con
altri forse dettati dallo spirito dei tempi, e come tali rappresentano, secondo alcuni
studiosi di massoneria, probabili ostacoli all’espansione di coscienza suggerita
nella via iniziatica. Si tratta del passo secondo il quale i candidati devono esser
"non schiavi, non donne, non uomini immorali e scandalosi, ma di buona
reputazione". Evidentemente l’interdizione dell’accesso in Loggia agli
schiavi rappresentava un tributo alla realtà dell’epoca, in essenza certo non
attuale; l’esclusione delle donne aveva la duplice valenza tradizionale ed iniziatica
(v. Massoneria e Donna). Infine l’ultima preclusione era di tono squisitamente
morale. Qualche perplessità nasce dalla considerazione che tre diverse motivazioni tanto
eterogenee siano state sbrigativamente condensate in un unico charge e così
omologate, poiché esse rivestono importanza diversificata, mentre sono sicuramente
foriere di profonde implicazioni. Gli A. si diffondono poi sulla deontologia massonica
dentro e fuori la Loggia, mutuando cospicui elementi dalla tradizione operativa: vi si
raccomandano la prudenza nella trattazione dei segreti del mestiere, l’armonia tra i
membri dell’Arte, la sobrietà di condotta nei divertimenti e la temperanza nei
convivii, la pacifica soluzione "intra moenia" delle eventuali
controversie tra i Muratori. Nella conclusione si invitano i Fratelli all’Amore
fraterno, già definito "la pietra di fondazione e di volta, il cemento e la
gloria di questa antica Fratellanza", affinché "tutti possano vedere la
benefica influenza della Muratoria, come tutti i veri Muratori hanno fatto dal principio
del mondo, e faranno fino alla fine dei tempi. Amen, così sia".
Anticlericalismo: Tendenza di pensiero a carattere politico e sociale, che si oppone all’ingerenza del potere ecclesiastico nella gestione degli affari di uno stato. Secondo il Magnin (Laicismo e laicità, Parigi, 1930) "Se per A. si
intende un’opposizione al clero, per ragioni più o meno valide, si può affermare
che esso è quasi sempre esistito nella storia dell’uomo. Allorché i profeti ebrei
criticavano aspramente alcuni sacerdoti che distinguevano il culto dalla legge morale,
essi erano anticlericali. Quando Buddha rigettava il regime delle caste ed i privilegi del
Brahma, anch’egli faceva dell’A.". Analizzando il fenomeno
dell’A. medievale, D. Hay (Profilo storico del Rinascimento italiano, Ediz.
Sansoni, 1966) osserva: "L’esistenza di un sentimento anticlericale in ogni
parte della cristianità medievale è, senza dubbio, un fatto fondamentale che tende ad
essere troppo spesso trascurato o soffocato di fronte alla fede egualmente indubbia delle
masse popolari. In un certo senso l’A. è possibile solo per i veri credenti;
la Chiesa soddisfa le loro ardenti esigenze spirituali, il clero suscita il loro odio ed
il loro disprezzo. Indubbia pure la venerazione di cui era oggetto il sacerdote
all’altare, ma come dimenticare l’odio od almeno il sospetto ch’egli
suscitava varcando la soglia della piazza del mercato. Lo stesso atteggiamento di Dante
consiste proprio in un simile disprezzo per il papa e per il clero, ed in una simile
riverenza per la Chiesa e per la religione. Si può arrivare a supporre che l’odio
verso il clero fosse in proporzione alla sua preminenza in ogni comunità. Esso era
ovviamente inasprito da accuse di cumulo di prebende, di ignoranza e di immoralità, molte
delle quali sembrano ben fondate".
Antico
e Mistico Ordine della Rosa Croce: Denominazione
dell’attuale Ordine noto universalmente attraverso la sua sigla A.M.O.R.C. (v.).
 Antico e Primitivo Rito di Memphis e
Misraim: Rito Massonico nato dalla definitiva fusione dei riti già confederati di
Memphis e di Misraim, avvenuta nel 1899, ma già fin dal 1881 preparata dal Gran Maestro
Giuseppe Garibaldi. Sul contenuto e sulla struttura del rito è opportuno citare il Rituale
dei Gradi simbolici della Massoneria di Memphis e Misraim di F. Brunelli: "I
95 gradi del R. debbono essere considerati come un deambulatorio in cui riposano i vecchi
gradi massonici che non sono più praticati, e non una scala di valori. Il R. è
un’opportunità di studio e di approfondimento di tutte le correnti che sono esistite
nella Massoneria dalla sua costituzione ad oggi, ed altresì un’opportunità di
realizzare praticamente la comprensione del Gran Segreto e la sua realizzazione" (R. Ambelain). Le Logge del R. lavorano alla Gloria del Sublime Artefice dei Mondi, od Alla Gloria del Grande Architetto dell’Universo (Art. 17 Gr. Cost.). "Il R. è deista e spiritualista, il che esige la credenza nell’immortalità dell’anima, od almeno, in una certa perennità postuma per questa. Qui si arresta la dogmatica del R., che non è legato e non dipende da alcuna religione particolare, e lascia ogni suo membro in una piena e totale libertà di opinione" (Art. 19 Gr. Cost.). I gradi di istruzione conferiti dal Rito sono divisi in tre serie che costituiscono: Dal 1° al 3° grado la Massoneria simbolica; dal 4° al 33° grado la Massoneria cabalistica, con gradi in buona parte coincidenti con quelli del R.S.A.A.; dal 34° al 66° grado la Massoneria ermetica e dal 67° al 90° la Massoneria alchemica od occulta. Questi sono gradi ispirati alle più diverse origini, da quelle egiziache, che rimandano all’esoterisno solare ed al culto misterico di una divinità ctonia, oltre che a prospettive persiane. Alcuni rivelano reminescenze vediche, mentre altri presentano uno sfondo cabalistico. I gradi dal 91° al 95° sono da considerarsi amministrativi o carismatici. Alla guida del Rito vi è un Sovrano Gran Maestro, denominato anche Gran Commendatore e Gran Hyerophante Generale, cui sono riservati il 96° ed il 97° grado, una particolare carica non elettiva ma trasmessa solo iniziaticamente e con validità vitalizia. Lo Hyerophante è il padre e l’istruttore dei suoi figli spirituali. Egli non dipende da essi, poiché non sono i figli che eleggono i loro genitori. I suoi diretti collaboratori, titolari degli ultimi gradi dal 91° in poi, hanno il potere di iniziazione individuale al di fuori di ogni tempio, e di tutte le officine, senati o consigli. Questo è il prezioso principio dell’iniziazione libera, che ha permesso la diffusione di altre grandi Fratellanze iniziatiche, quali il Pitagorismo (v.) ed il Martinismo (v.). I suoi simboli particolari non mancano di interesse: vi si ritrovano da una parte il triangolo radiante, dall’altra l’ypsilon segreto dei pitagorici, così come il doppio quadrato (materia-spirito). I tre mondi sono simboleggiati da tre cerchi concentrici, mentre la Qabbalah è rappresentata dalla scala di Giacobbe, simbolo anche del Luz e delle Tavole della Legge (v.). La corrente egizio-ellenica viene evidenziata dal dio Amon e dall’olivo sacro. I suoi Rituali tendono a purificare gli adepti, immettendoli in una vivificante atmosfera spirituale e ponendoli in relazione o in risonanza con i piani superiori alle debolezze umane, caricandoli delle grazie dell’Alto. È questo in fondo il solo, immenso, indicibile effetto della iniziazione verace: dare un senso alla vita, portare l’iniziato alla comunione con il cosmo, condurlo alla sua vera patria, quella celeste.
Antico e Primitivo Rito di Memphis e
Misraim: Rito Massonico nato dalla definitiva fusione dei riti già confederati di
Memphis e di Misraim, avvenuta nel 1899, ma già fin dal 1881 preparata dal Gran Maestro
Giuseppe Garibaldi. Sul contenuto e sulla struttura del rito è opportuno citare il Rituale
dei Gradi simbolici della Massoneria di Memphis e Misraim di F. Brunelli: "I
95 gradi del R. debbono essere considerati come un deambulatorio in cui riposano i vecchi
gradi massonici che non sono più praticati, e non una scala di valori. Il R. è
un’opportunità di studio e di approfondimento di tutte le correnti che sono esistite
nella Massoneria dalla sua costituzione ad oggi, ed altresì un’opportunità di
realizzare praticamente la comprensione del Gran Segreto e la sua realizzazione" (R. Ambelain). Le Logge del R. lavorano alla Gloria del Sublime Artefice dei Mondi, od Alla Gloria del Grande Architetto dell’Universo (Art. 17 Gr. Cost.). "Il R. è deista e spiritualista, il che esige la credenza nell’immortalità dell’anima, od almeno, in una certa perennità postuma per questa. Qui si arresta la dogmatica del R., che non è legato e non dipende da alcuna religione particolare, e lascia ogni suo membro in una piena e totale libertà di opinione" (Art. 19 Gr. Cost.). I gradi di istruzione conferiti dal Rito sono divisi in tre serie che costituiscono: Dal 1° al 3° grado la Massoneria simbolica; dal 4° al 33° grado la Massoneria cabalistica, con gradi in buona parte coincidenti con quelli del R.S.A.A.; dal 34° al 66° grado la Massoneria ermetica e dal 67° al 90° la Massoneria alchemica od occulta. Questi sono gradi ispirati alle più diverse origini, da quelle egiziache, che rimandano all’esoterisno solare ed al culto misterico di una divinità ctonia, oltre che a prospettive persiane. Alcuni rivelano reminescenze vediche, mentre altri presentano uno sfondo cabalistico. I gradi dal 91° al 95° sono da considerarsi amministrativi o carismatici. Alla guida del Rito vi è un Sovrano Gran Maestro, denominato anche Gran Commendatore e Gran Hyerophante Generale, cui sono riservati il 96° ed il 97° grado, una particolare carica non elettiva ma trasmessa solo iniziaticamente e con validità vitalizia. Lo Hyerophante è il padre e l’istruttore dei suoi figli spirituali. Egli non dipende da essi, poiché non sono i figli che eleggono i loro genitori. I suoi diretti collaboratori, titolari degli ultimi gradi dal 91° in poi, hanno il potere di iniziazione individuale al di fuori di ogni tempio, e di tutte le officine, senati o consigli. Questo è il prezioso principio dell’iniziazione libera, che ha permesso la diffusione di altre grandi Fratellanze iniziatiche, quali il Pitagorismo (v.) ed il Martinismo (v.). I suoi simboli particolari non mancano di interesse: vi si ritrovano da una parte il triangolo radiante, dall’altra l’ypsilon segreto dei pitagorici, così come il doppio quadrato (materia-spirito). I tre mondi sono simboleggiati da tre cerchi concentrici, mentre la Qabbalah è rappresentata dalla scala di Giacobbe, simbolo anche del Luz e delle Tavole della Legge (v.). La corrente egizio-ellenica viene evidenziata dal dio Amon e dall’olivo sacro. I suoi Rituali tendono a purificare gli adepti, immettendoli in una vivificante atmosfera spirituale e ponendoli in relazione o in risonanza con i piani superiori alle debolezze umane, caricandoli delle grazie dell’Alto. È questo in fondo il solo, immenso, indicibile effetto della iniziazione verace: dare un senso alla vita, portare l’iniziato alla comunione con il cosmo, condurlo alla sua vera patria, quella celeste.
 Ankh: Termine egiziano antico designante la croce ansata, il simbolo della vita come nodo che scioglie la morte. A. è l’esatto contrario della morte, in quanto rappresenta la vita per l’eternità, una linea verticale che ne incrocia una orizzontale (v. Croce) con, nel punto d’incontro, l’inizio di un nuovo ciclo: una vita riattivata. Identifica quindi il passato, il presente ed il futuro: ieri, oggi e domani. È l’eternità tra le mani dell’uomo, davanti alle sue mani ed alle sue narici. Significa anche aprire la strada al soffio, e lasciar scorrere l’acqua liberamente, nutrendo il grande corpo della Terra. Al centro un chicco di grano: dopo la sua putrefazione esso sta finalmente per germogliare, è vivo.
Ankh: Termine egiziano antico designante la croce ansata, il simbolo della vita come nodo che scioglie la morte. A. è l’esatto contrario della morte, in quanto rappresenta la vita per l’eternità, una linea verticale che ne incrocia una orizzontale (v. Croce) con, nel punto d’incontro, l’inizio di un nuovo ciclo: una vita riattivata. Identifica quindi il passato, il presente ed il futuro: ieri, oggi e domani. È l’eternità tra le mani dell’uomo, davanti alle sue mani ed alle sue narici. Significa anche aprire la strada al soffio, e lasciar scorrere l’acqua liberamente, nutrendo il grande corpo della Terra. Al centro un chicco di grano: dopo la sua putrefazione esso sta finalmente per germogliare, è vivo.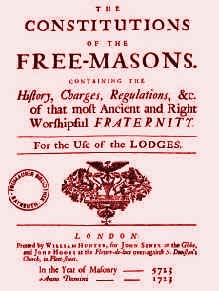 dell’Arte, a causa della loro tranquillità e
lealtà; per cui essi praticamente risposero ai cavilli dei loro avversari e promossero
l’onore della Fraternità, che sempre fiorì nei tempi di pace. Cosicchè se un
fratello divenisse un ribelle contro lo Stato, egli non deve essere favorito nella sua
ribellione, ma piuttosto compianto come uomo infelice …". Questo secondo
dovere (Del Magistrato Civile Supremo e Subordinato) è la codificazione del lealismo
massonico. Esso impegna l’Istituzione a mantenersi estraneo alla mischia politica, ed
a prestare obbedienza al governo civile. Come il primo, anche questo dovere riflette,
ancora una volta con una significativa variante, una norma reperibile presso i Massoni
operativi. Costoro infatti erano tenuti ad essere leali al re, "senza tradimento o
falsità", e ad emendare eventuali congiure di cui fossero a conoscenza, o ad
avvertire altrimenti "il sovrano od il suo consiglio". Qui troviamo
invece che l’eventuale ribelle dev’essere scoraggiato e compianto, ma non
necessariamente denunciato all’autorità od espulso dalla comunione massonica, anzi
il charge in oggetto recita: "sebbene la leale Fratellanza possa e debba
sconfessare la sua ribellione, e non dare ombra o base per la gelosia politica del governo
in essere, egli non può essere espulso dalla loggia, ed il suo vincolo rimane
irrevocabile". In sintesi, la Massoneria moderna si presenta con i tratti del
lealismo istituzionale nel rispetto delle clausole di coscienza, vale a dire dei diritti
individuali: un suo membro si assume piena ed esclusiva responsabilità per le proprie
azioni, e non può essere espulso dall’Ordine per motivi politici. L’ablazione
della catena fraterna può bensì aver luogo per motivi di indegnità o comunque per altri
"delitti", come soggiunge allusivamente lo stesso charge, e come
più dichiaratamente esplicitano le normative dei vari corpi massonici allorché, ad
esempio, similmente alle Costituzioni del Grande Oriente d’Italia, definiscono come
colpa massonica "ogni azione contraria alla lealtà, all’onore od alla
dignità della persona umana". Concretamente, l’atteggiamento della
Massoneria moderna rispetto all’eventualità di serpeggiamenti cospiratori al suo
interno, è di attenta vigilanza, affinché le velleità individuali d’ogni segno non
coinvolgano o non compromettano la neutralità dell’Istituzione, ragion per cui la
tendenza è quella di stroncarle preventivamente. Si pensi ai provvedimenti adottati da
Armando Corona, Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, per impedire la formazione
o la riformazione di organismi paralleli ed incontrollabili all’interno
dell’Obbedienza da lui presieduta (v. P2). Gli A. proseguono poi con la definizione
della Loggia ("Una Loggia è un luogo dove i Muratori si raccolgono ed operano
(…) ed ogni Fratello deve appartenere ad una, ed essere soggetto alle sue norme ed ai
regolamenti generali") e delle
dell’Arte, a causa della loro tranquillità e
lealtà; per cui essi praticamente risposero ai cavilli dei loro avversari e promossero
l’onore della Fraternità, che sempre fiorì nei tempi di pace. Cosicchè se un
fratello divenisse un ribelle contro lo Stato, egli non deve essere favorito nella sua
ribellione, ma piuttosto compianto come uomo infelice …". Questo secondo
dovere (Del Magistrato Civile Supremo e Subordinato) è la codificazione del lealismo
massonico. Esso impegna l’Istituzione a mantenersi estraneo alla mischia politica, ed
a prestare obbedienza al governo civile. Come il primo, anche questo dovere riflette,
ancora una volta con una significativa variante, una norma reperibile presso i Massoni
operativi. Costoro infatti erano tenuti ad essere leali al re, "senza tradimento o
falsità", e ad emendare eventuali congiure di cui fossero a conoscenza, o ad
avvertire altrimenti "il sovrano od il suo consiglio". Qui troviamo
invece che l’eventuale ribelle dev’essere scoraggiato e compianto, ma non
necessariamente denunciato all’autorità od espulso dalla comunione massonica, anzi
il charge in oggetto recita: "sebbene la leale Fratellanza possa e debba
sconfessare la sua ribellione, e non dare ombra o base per la gelosia politica del governo
in essere, egli non può essere espulso dalla loggia, ed il suo vincolo rimane
irrevocabile". In sintesi, la Massoneria moderna si presenta con i tratti del
lealismo istituzionale nel rispetto delle clausole di coscienza, vale a dire dei diritti
individuali: un suo membro si assume piena ed esclusiva responsabilità per le proprie
azioni, e non può essere espulso dall’Ordine per motivi politici. L’ablazione
della catena fraterna può bensì aver luogo per motivi di indegnità o comunque per altri
"delitti", come soggiunge allusivamente lo stesso charge, e come
più dichiaratamente esplicitano le normative dei vari corpi massonici allorché, ad
esempio, similmente alle Costituzioni del Grande Oriente d’Italia, definiscono come
colpa massonica "ogni azione contraria alla lealtà, all’onore od alla
dignità della persona umana". Concretamente, l’atteggiamento della
Massoneria moderna rispetto all’eventualità di serpeggiamenti cospiratori al suo
interno, è di attenta vigilanza, affinché le velleità individuali d’ogni segno non
coinvolgano o non compromettano la neutralità dell’Istituzione, ragion per cui la
tendenza è quella di stroncarle preventivamente. Si pensi ai provvedimenti adottati da
Armando Corona, Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, per impedire la formazione
o la riformazione di organismi paralleli ed incontrollabili all’interno
dell’Obbedienza da lui presieduta (v. P2). Gli A. proseguono poi con la definizione
della Loggia ("Una Loggia è un luogo dove i Muratori si raccolgono ed operano
(…) ed ogni Fratello deve appartenere ad una, ed essere soggetto alle sue norme ed ai
regolamenti generali") e delle 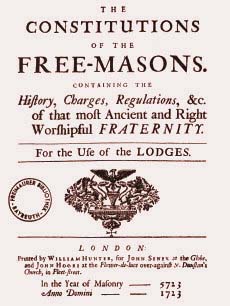 condizioni di ammissibilità di un profano in Loggia. Qui i
Doveri accorpano nelle clausole di iniziabilità fattori spiritualmente significativi con
altri forse dettati dallo spirito dei tempi, e come tali rappresentano, secondo alcuni
studiosi di massoneria, probabili ostacoli all’espansione di coscienza suggerita
nella via iniziatica. Si tratta del passo secondo il quale i candidati devono esser
"non schiavi, non donne, non uomini immorali e scandalosi, ma di buona
reputazione". Evidentemente l’interdizione dell’accesso in Loggia agli
schiavi rappresentava un tributo alla realtà dell’epoca, in essenza certo non
attuale; l’esclusione delle donne aveva la duplice valenza tradizionale ed iniziatica
(v. Massoneria e Donna). Infine l’ultima preclusione era di tono squisitamente
morale. Qualche perplessità nasce dalla considerazione che tre diverse motivazioni tanto
eterogenee siano state sbrigativamente condensate in un unico charge e così
omologate, poiché esse rivestono importanza diversificata, mentre sono sicuramente
foriere di profonde implicazioni. Gli A. si diffondono poi sulla deontologia massonica
dentro e fuori la Loggia, mutuando cospicui elementi dalla tradizione operativa: vi si
raccomandano la prudenza nella trattazione dei segreti del mestiere, l’armonia tra i
membri dell’Arte, la sobrietà di condotta nei divertimenti e la temperanza nei
convivii, la pacifica soluzione "intra moenia" delle eventuali
controversie tra i Muratori. Nella conclusione si invitano i Fratelli all’Amore
fraterno, già definito "la pietra di fondazione e di volta, il cemento e la
gloria di questa antica Fratellanza", affinché "tutti possano vedere la
benefica influenza della Muratoria, come tutti i veri Muratori hanno fatto dal principio
del mondo, e faranno fino alla fine dei tempi. Amen, così sia".
condizioni di ammissibilità di un profano in Loggia. Qui i
Doveri accorpano nelle clausole di iniziabilità fattori spiritualmente significativi con
altri forse dettati dallo spirito dei tempi, e come tali rappresentano, secondo alcuni
studiosi di massoneria, probabili ostacoli all’espansione di coscienza suggerita
nella via iniziatica. Si tratta del passo secondo il quale i candidati devono esser
"non schiavi, non donne, non uomini immorali e scandalosi, ma di buona
reputazione". Evidentemente l’interdizione dell’accesso in Loggia agli
schiavi rappresentava un tributo alla realtà dell’epoca, in essenza certo non
attuale; l’esclusione delle donne aveva la duplice valenza tradizionale ed iniziatica
(v. Massoneria e Donna). Infine l’ultima preclusione era di tono squisitamente
morale. Qualche perplessità nasce dalla considerazione che tre diverse motivazioni tanto
eterogenee siano state sbrigativamente condensate in un unico charge e così
omologate, poiché esse rivestono importanza diversificata, mentre sono sicuramente
foriere di profonde implicazioni. Gli A. si diffondono poi sulla deontologia massonica
dentro e fuori la Loggia, mutuando cospicui elementi dalla tradizione operativa: vi si
raccomandano la prudenza nella trattazione dei segreti del mestiere, l’armonia tra i
membri dell’Arte, la sobrietà di condotta nei divertimenti e la temperanza nei
convivii, la pacifica soluzione "intra moenia" delle eventuali
controversie tra i Muratori. Nella conclusione si invitano i Fratelli all’Amore
fraterno, già definito "la pietra di fondazione e di volta, il cemento e la
gloria di questa antica Fratellanza", affinché "tutti possano vedere la
benefica influenza della Muratoria, come tutti i veri Muratori hanno fatto dal principio
del mondo, e faranno fino alla fine dei tempi. Amen, così sia".