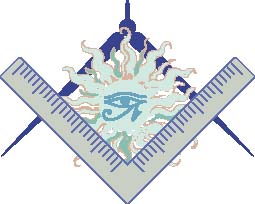 Compasso: Strumento costituito da due aste collegate da uno snodo, usato per tracciare circonferenze o per riportare un dato segmento. È considerato rappresentativo dell'esattezza, della ponderatezza, del rigore nel giudizio e nell'indagine. Il C. è un utensile mobile, quindi attivo, ed essendo ad apertura variabile, esprime la possibilità di ampliare il campo d'azione mentale e nella conoscenza di se stesso, rappresentando il modo di essere di colui che è pronto ad allargare la propria visione dell'Universo. Esso è inoltre ammonimento a contenere le azioni entro i limiti fissati dalla morale comune e dalla propria coscienza. Il C. evidenzia la condizione indispensabile per vivere in modo completo le esperienze esistenziali che ci vengono proposte dalla vita. Mentre la Squadra, con il suo angolo fisso a 90°, si presenta come mezzo di riferimento per le nostre osservazioni, il C. propone il nostro arricchimento interiore come fine mirato delle esperienze. I Simboli di Squadra e Compasso, uniti insieme in posizioni diverse a seconda del Grado in cui lavora ritualmente la Loggia, rappresentano il modello di sintesi operativa nella ricerca della conoscenza, fatto di rigorosità di giudizio e di volontà d'acquisizione della piena libertà interiore. La Massoneria considera il Compasso simbolo della Spiritualità. La Squadra (v.), il C ed il Libro della Legge Sacra (v.), uniti e sempre presenti sull'Ara massonica regolare
nel corso dei Lavori rituali, sono considerati e definiti le Tre Luci Maggiori della
Libera Muratoria.
Compasso: Strumento costituito da due aste collegate da uno snodo, usato per tracciare circonferenze o per riportare un dato segmento. È considerato rappresentativo dell'esattezza, della ponderatezza, del rigore nel giudizio e nell'indagine. Il C. è un utensile mobile, quindi attivo, ed essendo ad apertura variabile, esprime la possibilità di ampliare il campo d'azione mentale e nella conoscenza di se stesso, rappresentando il modo di essere di colui che è pronto ad allargare la propria visione dell'Universo. Esso è inoltre ammonimento a contenere le azioni entro i limiti fissati dalla morale comune e dalla propria coscienza. Il C. evidenzia la condizione indispensabile per vivere in modo completo le esperienze esistenziali che ci vengono proposte dalla vita. Mentre la Squadra, con il suo angolo fisso a 90°, si presenta come mezzo di riferimento per le nostre osservazioni, il C. propone il nostro arricchimento interiore come fine mirato delle esperienze. I Simboli di Squadra e Compasso, uniti insieme in posizioni diverse a seconda del Grado in cui lavora ritualmente la Loggia, rappresentano il modello di sintesi operativa nella ricerca della conoscenza, fatto di rigorosità di giudizio e di volontà d'acquisizione della piena libertà interiore. La Massoneria considera il Compasso simbolo della Spiritualità. La Squadra (v.), il C ed il Libro della Legge Sacra (v.), uniti e sempre presenti sull'Ara massonica regolare
nel corso dei Lavori rituali, sono considerati e definiti le Tre Luci Maggiori della
Libera Muratoria.
Competenze del Gran Maestro: Il Gran Maestro: a) promulga e fa eseguire le delibere della Gran Loggia e
della Giunta del Grande Oriente d'Italia; in caso di particolare necessità, adotta i
provvedimenti urgenti che debbono essere immediatamente sottoposti alla ratifica della
Giunta; b) promulga i Rituali; c) convoca e presiede la Giunta del Grande Oriente d'Italia
e ne coordina l'azione; assegna ai singoli membri compiti e funzioni particolari; d)
convoca e presiede il Consiglio dell'Ordine; e) nomina i Garanti di Amicizia presso le
Comunioni Massoniche Estere riconosciute dalla Gran Loggia; f) convoca, almeno tre volte
all'anno, i Presidenti dei Collegi Circoscrizionali; g) rilascia le Bolle di fondazione di
nuove Logge, i Brevetti ed i passaporti dei Fratelli; concede i nulla-osta previsti;
convoca le Logge inattive; h) può concedere, su proposta della Loggia, l'abbreviazione
dei termini di permanenza in uno dei primi due grradi; i) autorizza pubblicazioni ed
azioni nel mondo profano, riguardanti la Comunione Massonica Italiana, l) trasmette ai
Solstizi la parola semestrale alle Logge e, nel Solstizio d'Estate, la parola annuale ai
Maestri Venerabili; m) può sospendere i Fratelli o le Logge nei casi previsti; n) può,
su conforme parere della Giunta del Grande Oriente d'Italia, rendere nota, alle Comunioni
Estere ed anche al mondo profano, l'espulsione dall'Ordine di Fratelli o la demolizione
delle Logge; o) su istanza dei fratelli condannati con sentenza definitiva, può: 1)
concedere la grazia, limitatamente ai casi di condanna alla censura semplice ed alla
censura solenne; 2) promuovere il giudizio di revisione del processo davanti alla Corte
Centrale; p) su richiesta della Loggia, può concedere il nulla-osta per l'insediamento di
Dignitari che non abbiano il requisito prescritto dall'art. 21 della Costituzione (Art. 32
della Costituzione dell'Ordine).
Competenze della Gran Loggia: La Gran Loggia: a) emana, modifica, abroga ed interpreta in forma autentica le norme della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine; b) delibera su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti dalla Giunta del Grande Oriente d'Italia, nonché su ogni altro argomento che non sia di competenza di altri Organi della Comunione; c) approva i Rituali; d) discute la relazione morale del Grande Oratore, quella del Gran Segretario e quella del Consiglio dell'Ordine; e) esamina il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo, la relazione del Collegio dei Grandi Architetti Revisori, e vota separatamente sul bilancio consuntivo, sul bilancio preventivo e sulla relazione dei Grandi Architetti Revisori; f) elegge, nei casi previsti dal Regolamento dell'Ordine, il Gran Maestro ed i Membri effettivi della Giunta del Grande Oriente d'Italia, ad eccezione del Gran Segretario; g) celebra l'insediamento del Gran Maestro e dei Grandi Dignitari; h) elegge il Presidente ed i componenti del Collegio dei Grandi Architetti Revisori; i) elegge i Giudici necessari per il completamento della Corte Centrale; l) determina, su proposta della Giunta del Grande Oriente d'Italia, l'ammontare delle contribuzioni; m) delibera, su proposta della Giunta, il riconoscimento delle Comunioni Estere che abbiano i requisiti di cui all'art. 5; n) delibera l'instaurazione di rapporti con i Corpi Massonici Rituali che si conformino al principio di esclusività territoriale di ogni denominazione; o) nomina i Grandi Maestri Onorari su proposta del Consiglio dell'Ordine (Art. 28 della Costituzione dell'Ordine).
Competenze della Gran Giunta:
(G.O.I.) La Giunta del Grande Oriente d'Italia: a) dà
esecuzione alle norme della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine, ed alle
deliberazioni della Gran Loggia; b) discute e delibera sugli argomenti attinenti al
governo dell'Ordine; c) regola i rapporti con le Comunioni Estere e ne propone il
riconoscimento; d) può stipulare protocolli d'intesa con i Corpi Massonici Rituali; e)
dispone quanto necessario per il buon andamento della Comunione e per la diffusione del
pensiero massonico anche per mezzo di manifestazioni pubbliche a carattere nazionale; f)
esamina annualmente la relazione morale del Grande Oratore, amministrativa del Gran
Segretario e finanziaria del Gran Tesoriere, da inviare a tutte le Logge della Comunione
prima della Gran Loggia ordinaria; g) cura l'amministrazione della Comunione e predispone
i bilanci del Grande Oriente d'Italia; h) propone alla Gran Loggia l'ammontare delle
capitazioni, delle tasse d'ammissione, riammissione, affiliazione e passaggi di grado
dovute dai Fratelli, e determina, previo parere del consiglio dell'Ordine, l'ammontare di
eventuali contributi straordinari; i) determina il numero dei Consiglieri dell'Ordine e
degli Ispettori di Loggia; dichiara la decadenza degli Ispettori di Loggia e provvede per
la loro sostituzione; l) tiene il Libro d'Oro dell'Ordine; m) tiene aggiornati i ruoli
anagrafici della Comunione; n) cura il coordinamento dell'attività dei Collegi
Circoscrizionali sul piano nazionale; o) autorizza la formazione di Triangoli e stabilisce
il loro regolamento; p) approva la fondazione di logge, la modifica del loro titolo
distintivo ed il trasferimento della sede; cura i contatti con le singole Logge; ne
ratifica, verificata la legittimità, lo scioglimento e la fusione; ne dichiara
l'estinzione e ne dispone la cancellazione, ricorrendone i presupposti; q) cura
l'osservanza dei rituali e studia, avvalendosi della Commissione Rituali, le modifiche
eventuali; r) verifica la legittimità ed approva i Regolamenti di tutti gli organismi
della Comunione; s) concede l'exeat ai Fratelli appartenenti a Logge disciolte, estinte e
demolite; t) formula l'ordine del giorno della Gran Loggia; u) esprime i pareri previsti
dall'art. 36; v) può istituire Commissioni temporanee per lo studio di problemi che non
siano già di competenza delle Commissioni permanenti; z) delibera, per i fratelli di età
superiore ai 75 anni, la dispensa dagli oneri finanziari (Art. 38 della Costituzione
dell'Ordine).
Competenze della Loggia: (G.O.I.) La Loggia, nell'ambito della propria autonomia e sovranità,:
discute e delibera tutti gli argomenti che non siano in contrasto con la Costituzione ed
il Regolamento dell'Ordine; determina in Terzo Grado l'ammontare complessivo delle
capitazioni e di ogni altro contributo; procede ogni anno, all'epoca stabilita dal Gran
Maestro o quando necessario, nel rispetto del Regolamento dell'Ordine, all'elezione del
Maestro Venerabile e dei Dignitari; delibera sulle domande di ammissione e di
riammissione; delibera sulla decadenza (Art. 19 della Costituzione dell'Ordine).
Comportamento: Modo d'agire e d'essere, galateo (v.). Y (Massoneria) Per
ogni Libero Muratore esistono regole comportamentali profane e rituali, che è doveroso
rispettare se si intende percorrere il cammino iniziatico. Una delle doti essenziali del
Massone è rappresentata dalla coerenza, applicata soprattutto nei confronti dei Doveri e
dei Principi fatti propri dal momento dell’Iniziazione. Tra i principali doveri
imposti al Libero Muratore vi é l’assoluto ed incondizionato rispetto della
Costituzione e del Regolamento dell’Ordine, in cui sono elencate le principali norme
e regole istituzionali. Profanamente l’Iniziato è tenuto a mantenere una condotta in
linea (coerenza) con i principi muratori, che pertanto debbono trovare riscontro
nel C. tenuto anche al di fuori del Tempio, nel mondo profano. Per quanto riguarda invece
il C. rituale, ogni Massone (nessuno escluso) è tenuto ad osservare con la massima
diligenza una sorta di decalogo, ovvero:
· 1) lasciare fuori dal Tempio ogni metallo, durante la breve pausa di riflessione imposta dal Maestro delle Cerimonie nella Sala dei Passi Perduti (v.). Per metalli sono intesi i problemi, le ansie e le turbolenze che caratterizzano la vita profana, nonché tutte le passioni che dai metalli traggono origine. Solo in tale condizione il Massone è in grado di partecipare fattivamente ai Lavori architettonici;
· 2) squadrare
ritualmente il Tempio, partendo sempre con il piede sinistro e compiendo almeno
un giro completo sui quattro lati del pavimento a scacchi. Occorre seguire un percorso
rettilineo tra gli scacchi bianchi e quelli neri, fermandosi ad ogni angolo con i piedi a
squadra, col piede sinistro rivolto verso il lato ancora da percorrere, evitando andature
troppo dinoccolate o mantenere. Il senso di marcia all’apertura dei Lavori sarà
antiorario nel Rituale Simbolico, od orario secondo il Rituale Emulation. Il senso della
squadratura (detta anche marcia od ambulazione) sarà invertito alla
chiusura degli stessi. Secondo alcuni studiosi, tale senso è legato alla posizione dei
tre candelieri a stelo lungo, dette Luci. Il Tempio Massonico non è perennemente
consacrato come quello religioso, in quanto la consacrazione viene effettuata dai fratelli
ad ogni Tornata. Per cui all’apertura ognuno deve squadrare il Tempio in modo da
rivolgere la parte spirituale (v. Rebis) del corpo (sinistra) verso le Luci, per
trasmettervi la spiritualità dote essenziale poi richiesta dal rituale di consacrazione
del Tempio stesso. Alla chiusura la marcia sarà invertita, onde consentire ad ognuno di
portare con sé ed in sé l’essenza della Sapienza, della Bellezza e della Forza
creata nel corso dei Lavori, secondo quanto auspicato dai tre Dignitari al loro
spegnimento;
· 3) prendere compostamente posto tra le Colonne.
Essere composti in Tempio significa sedersi appoggiandosi allo schienale, mantenendo
quindi il busto in posizione pressoché eretta. I piedi dovranno essere tenuti con i
talloni ravvicinati, le punte dei piedi aperte ad angolo retto, le braccia abbandonate
lungo il corpo e le gambe, fino alle mani che saranno appoggiate sulle ginocchia
(posizione di Ra). A nessun Massone, per quanto blasonato possa essere, è consentita
l’assunzione di posizioni diverse da quella sopra indicata;
·
4) prestare la massima attenzione al rituale ed agli interventi, restando sempre agli
ordini del Maestro Venerabile, specie nell’uso della parola che dev’essere "sempre"
richiesta. Bisogna evitare di parlare con altri Fratelli, anche sottovoce, e soprattutto
lasciar liberamente parlare chi ha ricevuto autorizzazione a farlo. Essenziale è evitare
atti od espressioni polemici o provocatori nei confronti dei Fratelli. Qualsiasi azione
che risulti al di fuori di quanto esposto è contrario alla tradizione ed all’etica
muratoria, e può essere formalmente censurato sia dal Maestro Venerabile (come dirigente
dei Lavori) che dal primo Sorvegliante (quale responsabile dell’Armonia della Loggia)
che dall’Oratore (in quanto Custode della Legge). Ogni infrazione a questa regola
può essere punita anche con l’allontanamento (v.) dai Lavori;
·
5) ogni qual volta ci si alza in piedi, le posizioni da assumere possono essere soltanto
due: all’Ordine nel grado, specie quando comandato dal Maestro Venerabile,
oppure di "Rispetto", con la mano destra appoggiata all’altezza del
cuore;
· 6) nel Sacco delle Proposte Tacite (v) vanno
introdotte istanze, richieste e proposte (di passaggio di Grado od aumento di Salario);
vanno consegnate con la mano destra, lato maschile e della materia (v. Rebis),
ovvero della mente; e la mano va visibilmente aperta dopo l’operazione, a
dimostrazione che nulla è stato tolto di quanto eventualmente deposto da altri;
· 7) il Tronco della Vedova (v.) va onorato con la mano sinistra,
quella del cuore, il lato spirituale, ed al termine dell’offerta non va mai aperta,
dato che dal Tronco si può anche prelevare se si è in stato di bisogno, una condizione
che non va certo ostentata;
· 8) al termine dei Lavori, il
Massone lascia il proprio posto per seguire il Maestro delle Cerimonie nella squadratura
di uscita dal Tempio;
· 9) nella Sala dei Passi Perduti ognuno
dovrà infine attendere l’uscita dal Tempio dei Dignitari di Loggia, mantenendo in
silenzio la posizione di rispetto fino alla concessione della libertà da parte del
Maestro Venerabile.
· 10) ogni Massone deve frequentare
assiduamente le Tornate di Loggia, un diritto-dovere inderogabile e fondamentale, verso il
quale il Governo della Loggia non può comportarsi né con superficialità né con
eccessiva tolleranza. Imperativo il dovere di giustificare anticipatamente al Maestro
Venerabile ogni forzata assenza, dettagliandone la motivazione. Infine sul tema del C. non
si può certo ignorare né sottovalutare quanto il Grande Oriente d’Italia ha
ritenuto opportuno portare alla conoscenza dei Fratelli alla sua Obbedienza, e che viene
qui riportato integralmente: "Nei casi in cui l'intuizione porta l'uomo a
privilegiare la vita basata sull'essere piuttosto che sull'avere, allora i modi d'essere
assumono primaria importanza, ed anche significati ai quali è doveroso rivolgere tutta
l'attenzione. Per poter vivere pienamente la potenza dell'essere, è necessario sviluppare
interiormente una profonda coerenza armonica con il C. Tale coerenza armonica non
può essere raggiunta percorrendo un cammino solitario, escludendo il confronto diretto
con la vita esteriore e con la realtà rappresentata dagli altri esseri umani. Il Lavoro
effettuato nelle Logge porta però all'esperienza diretta della coerenza di modi di essere
armonici, conseguibile attraverso un'azione di ricerca continua, condotta
coralmente da parte dei Fratelli che ad esse appartengono"
Compostela: Località spagnola in cui ha sede un celebre santuario, denominato Santiago da Compostela (v.), mèta di grandi pellegrinaggi fin dal primo medioevo.
Comunione Massonica: Espressione indicante l’insieme di tutti i Liberi Muratori appartenenti ad uno Stato. Il termine può essere considerato sinonimo di Obbedienza, di Grande Oriente e di Gran Loggia.
Comunioni Massoniche Estere: Il Grande Oriente d’Italia può scambiare Garanti d’Amicizia con le C.M.E. legittimamente e regolarmente costituite, che abbiano giurisdizione e sovranità esclusive e che osservino principi non in contrasto con quelli propugnati dal G.O.I. (Art. 2 della Costituzione dell’Ordine). Il G.O.I delibera, su proposta della Giunta, il riconoscimento delle C.M.E. che abbiano i requisiti cui all’Art. 5, e delibera l’instaurazione di rapporti con i Corpi Massonici Rituali che si conformino al principio di esclusività territoriale di ogni denominazione (v. Metodi del G.O.I.)
Conciliarismo: Dottrina secondo la quale il Concilio (v.) è superiore al papa. Si radica nel principio giuridico (decreto di Graziano) secondo cui il pontefice può essere giudicato dalla Chiesa nel caso di sospetta eresia. Questa tesi fu particolarmente sostenuta da Marsilio da Padova (1275-1343) con l’opera Defensor pacis, condannata da Giovanni XXII (1327). Ad
essa si uniformarono l’inglese Guglielmo Occam (1290-1350) ed il francese Pietro
d’Ailly (1350-1425). Anche il Concilio di Trento (1545-63) condannò il C., che
rivisse però nel gallicanesimo francese. Il Concilio Vaticano I (1870) lo condannò in
modo definitivo, proclamando il dogma dell’infallibilità papale (v.).
Concilio: Denominazione della riunione legittima dei vescovi cattolici per deliberare in materia ecclesiastica. Può essere ecumenico, provinciale, metropolitano e plenario. Si contano 21 C. ecumenici: 1) Niceno I (325) contro l’arianesimo; 2) Costantinopolitano (381) contro i macedoniani; 3) Efesino (431) contro Nestorio, 4) Calcedonese (451) contro il monofisismo; 5) Costantinopolitano II (553) contro i tre Capitoli; 6) Costantinopolitano III (680-81) contro il monotelismo; 7) Niceno II (787) contro gli iconoclasti; 8) Costantinopolitano IV (869) contro Fozio; 9) Lateranense I (1123) contro la simonia ed il nicolaismo, e per sancire l’indipendenza della Chiesa dal potere temporale; 10) Lateranense II (1139) contro lo scisma di Pierleoni; 11) Lateranense III (1179) per ratificare la pace con Federico Barbarossa; 12) Lateranense IV (1215), oltre a condannare le più importanti eresie medievali, precisa alcune norme disciplinari; 13) di Lione I (1245) con la scomunica di Innocenzo IV contro Federico II; 14) di Lione II (1274) per l’unione delle Chiese romana e greca; 15) di Vienne (1311-12), indetto dal primo papa avignonese, Clemente V, per la scomunica dei Templari; 16) di Costanza (1414-18) per porre fine allo scisma d’Occidente; 17) di Firenze (1439-43) per l’unione della Chiesa greca; 18) Lateranense V (1512-17) per la riforma della Chiesa; 19) di Trento (1545-63) contro la Riforma protestante e per la Controriforma cattolica; 20) Vaticano I (1869-70) per sancire l’infallibilità del papa; 21) Vaticano II (1962-659, sotto i papi Giovanni XXIII e Paolo VI, l’unico con carattere esclusivamente pastorale, "espressione della
preoccupazione della Chiesa per l’uomo". Vi fu anche un C. di Basilea
(1431-49), considerato ecumenico solo fino alla fine della sua XXV sessione (1433-.37).
Gli atti dei C. sono stati raccolti in collezioni dette Conciliari. Y
(Buddhismo) Riconosce come legittimi solo i primi quattro dei suoi cinque C.: 1) di
Rajagriha (180 a.C.), indetto subito dopo l’ascesa del Buddha sakyamuni nel
Nirvana, e presieduto dal discepolo Mahakasyapa, cui parteciparono, con 500 altri
monaci, anche Ananda che si occupò dei discorsi di Buddha (sutra) ed Upali
dei trattati disciplinari (vinaya); 2) di Vaisali (377 a.C.) con la condanna dei
monaci procacciatori di ricchezze; 3) di Pataliputra (341 a.C.), indetto dopo un grande
scisma, tentò di riconciliare la maggioranza (mahasamghika) e gli anziani
conservatori (sthavira); 4) di Pataliputra II (249 a.C.), sotto il re Asoka, con la
condanna dei sarvastivadin, fautori di violenze, che furono spretati, dopo
un’assemblea a Ceylon (89 a.C.), dove vennero redatti i testi pali (Tripitaka),
si tenne un ulteriore C.: il 5° del Kashmir (prima metà del II secolo d.C.), in cui fu
compilato il canone sanscrito dei sarvastivadin, presieduto da Afvaghosa,
sotto l’imperatore kushana Kaniska: vi si gettarono anche le basi del primo
buddhismo mahayana (v.). Y (Massoneria) Il C.,
l’inglese Council, definisce la camera criptica del Rito Americano (v.) o di York.
Concistoro: Termine derivato dal tardo latino consistorium, da consistere, fermarsi. Nella Chiesa
cattolica definisce la solenne adunanza di tutti i cardinali presenti in Roma, presieduta
dal papa, per la trattazione di importanti affari relativi al governo della Chiesa
universale. Si distinguono tre specie di C.:
* segreto,
con l’intervento dei soli cardinali;
* semipubblico,
al quale partecipano anche i vescovi le cui sedi distino meno di 100 miglia da Roma;
* pubblico, cui prendono parte anche altri dignitari
ecclesiastici e laici della corte pontificia, e membri del corpo diplomatico accreditato
presso la Santa Sede.
Tra gli argomenti trattati nel C. segreto normalmente vi sono
le nomine di nuovi cardinali, l’annuncio di eventuali rinunce di cardinali, la nomina
del cardinale Camerlengo (v.), domanda ai cardinali se si possa procedere alla
canonizzazione di qualche beato la cui causa sia stata istruita dalla Congregazione dei
Riti. Nel C. pubblico si ha la prima perorazione (istanza di canonizzazione) delle
cause di santi già trattate nel C. segreto. Nel C. semipubblico, che si tiene a
distanza di pochi giorni o mesi dai precedenti, il papa chiede se si possa procedere alle
canonizzazioni di cui si è parlato nei c. precedenti. Nella Chiesa protestante, il C. è
un organo costituito da Calvino a Ginevra (detto anche concistorio), composto da sei
pastori e da dodici anziani, col compito di giudicare la disciplina religiosa e morale dei
cittadini. Oggi in tutte le Chiese riformate (esclusi i presbiteriani) il C. è formato
dal pastore del luogo, da anziani e diaconi, con il compito di vigilare gli interessi
spirituali della comunità, e provvedere alle opere di carità e di assistenza.
Conclave: Termine avente il significato letterale di camera chiusa a chiave. Indica sia il luogo dove i cardinali procedono all’elezione del pontefice sia il complesso dei cardinali partecipanti. L’origine della parola C. risale ai tempi dell’elezione del successore di Clemente V (1268). Quando i 18 cardinali riuniti a Viterbo, dopo diciotto mesi di riunioni non erano ancora riusciti ad accordarsi su un nome, i cittadini viterbesi dapprima bloccarono rigorosamente gli ingressi del palazzo papale, poi limitarono il vitto dei cardinali a solo pane ed acqua. Gregorio IX, eletto in quell’occasione, con la costituzione "Ubi periculum" (1274) stabiliva condizioni molto rigide per
l’elezione del papa, che quasi sanzionavano l’opera dei cittadini di Viterbo.
Parte di queste disposizioni sono state sostanzialmente recepite dalla costituzione "Vacantis
Sede Apostolica" di Pio X (1914), che regola l’attuale elezione del papa,
con le lievi modifiche apportate da Pio XII con la costituzione "Vacantis
Apostolicae Sedis" (1945), fra cui la più importante disposizione è la
richiesta per l’elezione di un voto in più oltre i due terzi dei suffragi, come
stabilito in origine. I cardinali debbono riunirsi in C. entro non più di 18 giorni dalla
morte del papa, prestare giuramento dinanzi al Camerlengo (v.), quindi il maresciallo del
C. (per antica tradizione è un membro della famiglia Chigi) provvede
dall’esterno alla chiusura delle porte. Dal XV al XVIII secolo i C. si tennero in
Vaticano; dopo la morte di Pio VII (1823) il C. si trasferì nel palazzo del Quirinale,
fino all’elezione di Pio IX (1846). Alla sua morte (1878) il C. ritornò in Vaticano,
dove si svolge tuttora nella cappella Sistina. Cardinali e conclavisti (ogni cardinale ha
diritto ad un segretario laico) sono tenuti al più assoluto segreto sotto pena di
scomunica. Secondo la tradizione, sul C. aleggia l’influsso superiore
dell’Eggregoro (v.), in questo caso dello Spirito Santo, che porta i convenuti ad
esprimere il proprio voto esclusivamente in funzione del bene reale della Chiesa. Si fanno
due votazioni al mattino e due la sera. Dopo ogni votazione le schede vengono bruciate
nell’apposito caminetto: se la votazione risulta negative con le schede viene
bruciata della pece che provoca una fumata nerastra; in caso di risultato positivo vengono
invece bruciate solamente le schede, onde provocare una fumata bianca, che segnala
all’esterno l’evento. In questa occasione tutti i baldacchini che sovrastano gli
stalli cardinalizi vengono abbassati, eccetto quello dell’eletto. Dopo che questi ha
accettato la nomina, riceve l’adorazione da parte di tutti i cardinali; quindi il
decano dei diaconi annuncia al popolo l’avvenuta elezione con la formula: "Annuncio
vobis gaudium magnum. Habemus papam dominum cardinalem (nome) qui sibi nomen
imposuit (nome papale)". Il nuovo papa, rivestito degli abiti bianchi,
impartisce poi la sua prima benedizione al popolo, affacciandosi al finestrone della
basilica di San Pietro.
Concordato: Atto bilaterale mediante il quale il pontefice ed il capo dello Stato si accordano in generale sulla condizione giuridica della religione e della Chiesa cattolica nel territorio dello Stato, oppure regola particolari questioni religiose od ecclesiastiche. Talvolta gli obblighi vicendevoli di un solo atto formano oggetto di due atti distinti; così il C. di Worms del 1122 risulta del "privilegium Calixtinum" e della "Praescriptio
Henrici V". Vengono annoverati anche fra i C. gli atti emanati dai pontefici in
seguito ad accordi con lo Stato, che dà successivamente il benestare agli atti stessi.
Dal C., come contratto non sorgono che diritti ed obbligazioni reciproci dello Stato
contraente e della santa Sede; non sorgono né diritti né obbligazioni per i terzi, e
quindi neppure per i soggetti allo Stato od alla Chiesa. Gli atti dello Stato e della
santa Sede possono consistere in atti di legislazione o di amministrazione dei contraenti;
particolare importanza rivestono gli atti legislativi, cioè la trasformazione delle
clausole concordatarie in diritto oggettivo dello Stato ed in diritto territoriale della
Chiesa. Per quanto riguarda quest’ultima, la santa Sede non usa emanare
un’apposita legge, ma si limita a pubblicare negli Acta Apostolicae Sedis il
testo del C. con il protocollo dello scambio delle ratifiche, volendo con ciò
implicitamente emanare e pubblicare le norme di diritto canonico territoriale contenute
nel C., che essa ha assunto l’obbligo di statuire in deroga al diritto comune. Gli
Stati procedono secondo le norme del proprio diritto costituzionale, attenendosi
effettivamente alle stesse disposizioni che valgono per i trattati internazionali. Non vi
sono norme particolari sull’interpretazione e l’esecuzione dei C. diverse da
quelle comuni a tutti i contratti in generale. I C. sfuggono alla competenza della corte
permanente gi giustizia internazionale. Ammessa la natura contrattuale del C.,
indubbiamente è illegale la denuncia unilaterale, mentre invece l’inadempimento o la
violazione del C. da una parte possa dar luogo dall’altra parte alla dichiarazione di
ritenersi sciolta dalle obbligazioni assunte. Generalmente si ritiene che i C. diano
sempre stipulati con l’implicita pattuizione che essi si estinguano se vengono
sostanzialmente a mutare le condizioni di fatto esistenti al momento della conclusione; si
ritiene però anche che non si tratti di volontà presunta delle parti, ma
dell’esistenza di una norma generale relativa a tutti i contratti, secondo la quale
il mutamento sostanziale della situazione di fatto è causa di estinzione del contratto, e
quindi anche dei C. Certo sono gli Stati a rivendicare a sé il diritto di dichiarare
cessati gli effetti del c. se, per le mutate condizioni di fatto, essa riesca di danno
alla società civile. Sono da considerarsi famosi i C.: il citato di Worms (1122),
stipulato tra Callisto II e l’imperatore Enrico V, con cui si pose fine alle lotte
per l’investitura; di Bologna (1516) tra Leone X e l’imperatore di Francia
Francesco I, che fissava le modalità per la concessione dei benefici e per la nomina dei
vescovi; del 1801, tra Napoleone Bonaparte e Pio VII, con cui si ristabiliva in Francia
l’autorità del papa dopo la Rivoluzione francese; i Patti lateranensi del
1929 con lo Stato italiano. Tra gli altri, si ricordano quelli stipulati con Federico
Barbarossa (1176), Federico II (1212), il Regno delle due Sicilie (1818), la Russia
(1847), la Prussia (1848), la Spagna (1851), l’Austria (1885), la Francia (1906), la
Lettonia (1922), la Baviera (1925), la Polonia (1925), la Romania (19279, la Lituania
(19279, la Prussia (1929), il Baden (1932), l’Austria (1933) e la Germania (1933).
Papa Martino V resta famoso per aver stipulato C. con molti Stati europei (1417-31), dopo
il Grande Scisma d’Occidente.
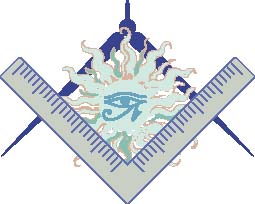 Compasso: Strumento costituito da due aste collegate da uno snodo, usato per tracciare circonferenze o per riportare un dato segmento. È considerato rappresentativo dell'esattezza, della ponderatezza, del rigore nel giudizio e nell'indagine. Il C. è un utensile mobile, quindi attivo, ed essendo ad apertura variabile, esprime la possibilità di ampliare il campo d'azione mentale e nella conoscenza di se stesso, rappresentando il modo di essere di colui che è pronto ad allargare la propria visione dell'Universo. Esso è inoltre ammonimento a contenere le azioni entro i limiti fissati dalla morale comune e dalla propria coscienza. Il C. evidenzia la condizione indispensabile per vivere in modo completo le esperienze esistenziali che ci vengono proposte dalla vita. Mentre la Squadra, con il suo angolo fisso a 90°, si presenta come mezzo di riferimento per le nostre osservazioni, il C. propone il nostro arricchimento interiore come fine mirato delle esperienze. I Simboli di Squadra e Compasso, uniti insieme in posizioni diverse a seconda del Grado in cui lavora ritualmente la Loggia, rappresentano il modello di sintesi operativa nella ricerca della conoscenza, fatto di rigorosità di giudizio e di volontà d'acquisizione della piena libertà interiore. La Massoneria considera il Compasso simbolo della Spiritualità. La Squadra (v.), il C ed il Libro della Legge Sacra (v.), uniti e sempre presenti sull'Ara massonica regolare
nel corso dei Lavori rituali, sono considerati e definiti le Tre Luci Maggiori della
Libera Muratoria.
Compasso: Strumento costituito da due aste collegate da uno snodo, usato per tracciare circonferenze o per riportare un dato segmento. È considerato rappresentativo dell'esattezza, della ponderatezza, del rigore nel giudizio e nell'indagine. Il C. è un utensile mobile, quindi attivo, ed essendo ad apertura variabile, esprime la possibilità di ampliare il campo d'azione mentale e nella conoscenza di se stesso, rappresentando il modo di essere di colui che è pronto ad allargare la propria visione dell'Universo. Esso è inoltre ammonimento a contenere le azioni entro i limiti fissati dalla morale comune e dalla propria coscienza. Il C. evidenzia la condizione indispensabile per vivere in modo completo le esperienze esistenziali che ci vengono proposte dalla vita. Mentre la Squadra, con il suo angolo fisso a 90°, si presenta come mezzo di riferimento per le nostre osservazioni, il C. propone il nostro arricchimento interiore come fine mirato delle esperienze. I Simboli di Squadra e Compasso, uniti insieme in posizioni diverse a seconda del Grado in cui lavora ritualmente la Loggia, rappresentano il modello di sintesi operativa nella ricerca della conoscenza, fatto di rigorosità di giudizio e di volontà d'acquisizione della piena libertà interiore. La Massoneria considera il Compasso simbolo della Spiritualità. La Squadra (v.), il C ed il Libro della Legge Sacra (v.), uniti e sempre presenti sull'Ara massonica regolare
nel corso dei Lavori rituali, sono considerati e definiti le Tre Luci Maggiori della
Libera Muratoria.