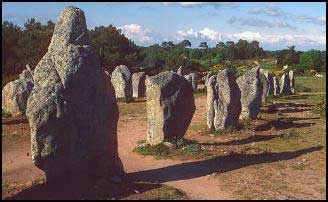 Menhir: Il
M. è una grossa pietra oblunga, piantata verticalmente sul terreno, mentre il dolmen è
costituito da tre pietre lunghe, due in verticale che reggono la terza, che è adattata a
tetto. Questi macigni vengono chiamati anche Megaliti (v.), dal greco megas,
(grande) e lithoz, (pietra). Li ritroviamo in tutta
Europa come semplici sassi isolati, oppure filari che rispondono ad una certa logica, o
ancora costruzioni complesse; di queste la più famosa è sicuramente quella di Stonehenge
(v.), in Gran Bretagna. I megaliti, collocati in genere dalle popolazioni locali, sono
antichissimi e la loro collocazione richiedeva una tecnica progredita. Noi siamo abituati
a considerare i nostri antenati europei come selvaggi che si limitavano ad andare a
caccia, vestirsi di pelli e mangiare carni crude ma in realtà erano capaci di pensare a
progetti ingegnosi e realizzarli. Infatti per mettere in verticale una pietra alta diversi
metri bisogna usare un sistema di cunei ed impalcature. Per fare poi un Dolmen
(v.), è necessario che l'impalcatura circondi tutto l'impianto. Per simili opere
servivano centinaia di uomini organizzati, e in questo senso è logico pensare a capi e
dipendenti, forse sacerdoti e fedeli, o forse scienziati in grado di farsi fornire
un'adeguata mano d'opera. Spesso i megaliti venivano trasportati da lontano, con zattere e
rulli, impresa questa non da poco considerando che in quelle epoche non era stata scoperta
ancora la ruota. Gli anni in cui cominciano a diffondersi i M. sono quelli del neolitico e
dell'età del bronzo. In Bretagna emergono pietroni innalzati duemila anni prima che gli
egiziani pensassero alle loro piramidi. In un sito chiamato Locmariaquer c'è poi il Gran
M., spezzato da un fulmine in quattro tronconi: in origine infatti pesava quasi 400
tonnellate, e per metterlo in piedi saranno occorsi certamente migliaia di uomini. Nella
campagna di Carnac sud bretone, migliaia di sassi furono allineati in file parallele per
centinaia e centinaia di metri mentre ad Avebury in Inghilterra sorgeva un cerchio di
megaliti, un centinaio almeno, simili a quelli di Stonehenge. Ma gli impianti più
affascinanti, oltre a quelli Britannici, sorgono a Malta: pilastri ciclopici che svettano
verso il cielo, mura e travi di marmo orizzontali che formano porte. E ancora camere
mortuarie in Irlanda, con i primi tentativi di formare una cupola o i megaliti sotterranei
dell'isola di Gavrinis, in Francia, dove ogni pietra è incisa con misteriosi motivi a
spirale o a zigzag od ancora i M. scolpiti della Corsica, che sono vere e proprie statue.
Opere queste affascinanti, che rivelano non solo conoscenze di ingegneria ma uno
straordinario senso artistico. Misteriosi i disegni, misteriosi gli scopi. A che cosa
dunque servivano queste costruzioni? Spesso erano monumenti funerari; alla base di molti
M. sono infatti stati trovati corpi di antichissimi defunti, anche famiglie intere. A
lungo si è creduto così che avessero una funzione religiosa, qualcuno ha anche parlato
per esempio dei Drudi e dei loro sacrifici umani. Ma in genere i megaliti risalgono ad
epoche molto anteriori. A Stonehenge le pietre sono disposte in modo da segnalare il
solstizio d'estate e la posizione più settentrionale della luna ogni 18 anni, al
solstizio d'inverno. Tenendo conto che in altre località molti M. sono stati spostati o
distrutti dalla mano dell'uomo, ci sono indizi che fanno pensare a calcoli sulle eclissi
di sole e di luna. Come spesso accadeva nei tempi remoti, è probabile che scienza e
religione andassero di pari passo. I sacerdoti erano infatti anche astronomi e astrologi,
ascoltati dai capitribù che fornivano gli uomini necessari per le grandi costruzioni
megalitiche. Misteriosamente però ad un certo punto, di colpo questa tecnica si estinse.
Anche di ciò non si conoscono le ragioni, ma forse gli impianti fissi non potevano
seguire gli spostamenti dell'arco celeste. Possiamo così immaginare ad esempio che un
sacerdote prevedesse un eclisse, e che questa non si sia verificata. Il popolo infuriato
decide così di distruggere l'osservatorio, non credendoci più. Questa è però solo
un'ipotesi come tante, ma d'altra parte per questi macigni sepolti nella terra e nel
tempo, tutto è limitato a pura ipotesi.
Menhir: Il
M. è una grossa pietra oblunga, piantata verticalmente sul terreno, mentre il dolmen è
costituito da tre pietre lunghe, due in verticale che reggono la terza, che è adattata a
tetto. Questi macigni vengono chiamati anche Megaliti (v.), dal greco megas,
(grande) e lithoz, (pietra). Li ritroviamo in tutta
Europa come semplici sassi isolati, oppure filari che rispondono ad una certa logica, o
ancora costruzioni complesse; di queste la più famosa è sicuramente quella di Stonehenge
(v.), in Gran Bretagna. I megaliti, collocati in genere dalle popolazioni locali, sono
antichissimi e la loro collocazione richiedeva una tecnica progredita. Noi siamo abituati
a considerare i nostri antenati europei come selvaggi che si limitavano ad andare a
caccia, vestirsi di pelli e mangiare carni crude ma in realtà erano capaci di pensare a
progetti ingegnosi e realizzarli. Infatti per mettere in verticale una pietra alta diversi
metri bisogna usare un sistema di cunei ed impalcature. Per fare poi un Dolmen
(v.), è necessario che l'impalcatura circondi tutto l'impianto. Per simili opere
servivano centinaia di uomini organizzati, e in questo senso è logico pensare a capi e
dipendenti, forse sacerdoti e fedeli, o forse scienziati in grado di farsi fornire
un'adeguata mano d'opera. Spesso i megaliti venivano trasportati da lontano, con zattere e
rulli, impresa questa non da poco considerando che in quelle epoche non era stata scoperta
ancora la ruota. Gli anni in cui cominciano a diffondersi i M. sono quelli del neolitico e
dell'età del bronzo. In Bretagna emergono pietroni innalzati duemila anni prima che gli
egiziani pensassero alle loro piramidi. In un sito chiamato Locmariaquer c'è poi il Gran
M., spezzato da un fulmine in quattro tronconi: in origine infatti pesava quasi 400
tonnellate, e per metterlo in piedi saranno occorsi certamente migliaia di uomini. Nella
campagna di Carnac sud bretone, migliaia di sassi furono allineati in file parallele per
centinaia e centinaia di metri mentre ad Avebury in Inghilterra sorgeva un cerchio di
megaliti, un centinaio almeno, simili a quelli di Stonehenge. Ma gli impianti più
affascinanti, oltre a quelli Britannici, sorgono a Malta: pilastri ciclopici che svettano
verso il cielo, mura e travi di marmo orizzontali che formano porte. E ancora camere
mortuarie in Irlanda, con i primi tentativi di formare una cupola o i megaliti sotterranei
dell'isola di Gavrinis, in Francia, dove ogni pietra è incisa con misteriosi motivi a
spirale o a zigzag od ancora i M. scolpiti della Corsica, che sono vere e proprie statue.
Opere queste affascinanti, che rivelano non solo conoscenze di ingegneria ma uno
straordinario senso artistico. Misteriosi i disegni, misteriosi gli scopi. A che cosa
dunque servivano queste costruzioni? Spesso erano monumenti funerari; alla base di molti
M. sono infatti stati trovati corpi di antichissimi defunti, anche famiglie intere. A
lungo si è creduto così che avessero una funzione religiosa, qualcuno ha anche parlato
per esempio dei Drudi e dei loro sacrifici umani. Ma in genere i megaliti risalgono ad
epoche molto anteriori. A Stonehenge le pietre sono disposte in modo da segnalare il
solstizio d'estate e la posizione più settentrionale della luna ogni 18 anni, al
solstizio d'inverno. Tenendo conto che in altre località molti M. sono stati spostati o
distrutti dalla mano dell'uomo, ci sono indizi che fanno pensare a calcoli sulle eclissi
di sole e di luna. Come spesso accadeva nei tempi remoti, è probabile che scienza e
religione andassero di pari passo. I sacerdoti erano infatti anche astronomi e astrologi,
ascoltati dai capitribù che fornivano gli uomini necessari per le grandi costruzioni
megalitiche. Misteriosamente però ad un certo punto, di colpo questa tecnica si estinse.
Anche di ciò non si conoscono le ragioni, ma forse gli impianti fissi non potevano
seguire gli spostamenti dell'arco celeste. Possiamo così immaginare ad esempio che un
sacerdote prevedesse un eclisse, e che questa non si sia verificata. Il popolo infuriato
decide così di distruggere l'osservatorio, non credendoci più. Questa è però solo
un'ipotesi come tante, ma d'altra parte per questi macigni sepolti nella terra e nel
tempo, tutto è limitato a pura ipotesi.
Mennoniti: Setta
cristiana anabattista, riformata nel 1536 dal sacerdote olandese Simonsz Menno (1496-1561)
che, convertitosi al luteranesimo, poi all’anabattismo (1534), espose le sue teorie
teologiche in Het Fundament des cristelycke Leer (Libro fondamentale della dottrina
cristiana, 1539). Due suoi seguaci codificarono poi la dottrina M. nella Confessione di
fede di Waterland (1580), nella quale vengono respinte, fra l’altro, la
trasmissibilità del peccato originale, la liceità della prestazione di giuramento,
l’uso delle armi, il rigidismo dogmatico della Chiesa cattolica e, in particolare, il
battesimo degli infanti, conferito solo in età adulta come segno della rinascita in
Cristo. Comunità di M. sorsero in Frisia, Holstein e Meclemburgo. Dopo un periodo di
persecuzioni, i M. vennero riconosciuti dall’Olanda (1579), e si diffusero poi anche
in Inghilterra, Germania, Svizzera, Ungheria, America settentrionale (dal 1663) e nella
Russia di Caterina II. Dopo la seconda guerra mondiale i M. raggiunsero gli Stati Uniti,
il Canada ed il Messico, arrivando a contare un totale di circa 500.000 aderenti. Fanno
comunque parte della grande famiglia degli Anabattisti (v.), che solo negli Stati Uniti
contano 15 milioni di adepti.
 Menorah: Nome ebraico del candelabro sacro collocato da Mosé nel Tabernacolo, accanto all’Arca della Santa Alleanza (v.). È costituito da sette braccia, con ventidue ingrossamenti (mandorle, boccioli, fiori ), tre per ogni braccio più uno sullo stelo principale. Al culmine di ciascun braccio è posta una fiamma. Alcuni associano ad ogni ingrossamento una lettera dell’alfabeto ebraico e, conseguentemente, della sua trasposizione numerica, considerandolo quindi parte della simbologia cabalistica. È ornamento del Tempio massonico, collocato accanto al Libro della Legge Sacra. L’accensione della M. avviene mediante un testimone, iniziando dalla triade dell’Emanazione, per passare poi a quella della Creazione ed a quella della Formazione: ultima quella centrale (Yod), lo spirito Creatore. Se le fiamme fossero numerate da 1 a 7, da sinistra a destra per chi le osserva rivolto verso l’Oriente, esse andrebbero accese secondo la sequenza 1-7-2-6-3.5-4. Qualcuno, per semplicità, ad ogni fiamma attivata pronuncia in chiaro le sette parole che compongono la scritta posta all’Oriente, ovvero A.G.D.G.A.D.U. Alcuni studiosi di simbologia esoterica considerano la M. simbolo della Luce dello Spirito e della Salvezza. Altri invece associano la M. alle sette Arti Liberali, la cui conoscenza è indispensabile per il Lavoro di ogni Iniziato, ovvero Grammatica, Retorica, Logica, Aritmetica, Geometria, Astronomia e Musica. Infine le sette braccia della M. vengono anche simbolicamente associati ai sette gradini magistrali ed a quelli della scala dei filosofi o di Giacobbe. La M. viene accesa esclusivamente per i Lavori rituali in terzo Grado, del Maestro Massone, ovvero nella Camera di Mezzo, normalmente dall’ex Maestro Venerabile.
Menorah: Nome ebraico del candelabro sacro collocato da Mosé nel Tabernacolo, accanto all’Arca della Santa Alleanza (v.). È costituito da sette braccia, con ventidue ingrossamenti (mandorle, boccioli, fiori ), tre per ogni braccio più uno sullo stelo principale. Al culmine di ciascun braccio è posta una fiamma. Alcuni associano ad ogni ingrossamento una lettera dell’alfabeto ebraico e, conseguentemente, della sua trasposizione numerica, considerandolo quindi parte della simbologia cabalistica. È ornamento del Tempio massonico, collocato accanto al Libro della Legge Sacra. L’accensione della M. avviene mediante un testimone, iniziando dalla triade dell’Emanazione, per passare poi a quella della Creazione ed a quella della Formazione: ultima quella centrale (Yod), lo spirito Creatore. Se le fiamme fossero numerate da 1 a 7, da sinistra a destra per chi le osserva rivolto verso l’Oriente, esse andrebbero accese secondo la sequenza 1-7-2-6-3.5-4. Qualcuno, per semplicità, ad ogni fiamma attivata pronuncia in chiaro le sette parole che compongono la scritta posta all’Oriente, ovvero A.G.D.G.A.D.U. Alcuni studiosi di simbologia esoterica considerano la M. simbolo della Luce dello Spirito e della Salvezza. Altri invece associano la M. alle sette Arti Liberali, la cui conoscenza è indispensabile per il Lavoro di ogni Iniziato, ovvero Grammatica, Retorica, Logica, Aritmetica, Geometria, Astronomia e Musica. Infine le sette braccia della M. vengono anche simbolicamente associati ai sette gradini magistrali ed a quelli della scala dei filosofi o di Giacobbe. La M. viene accesa esclusivamente per i Lavori rituali in terzo Grado, del Maestro Massone, ovvero nella Camera di Mezzo, normalmente dall’ex Maestro Venerabile.
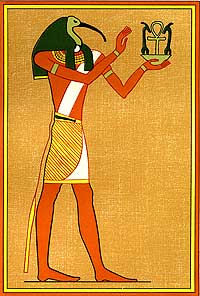 Mercurio: (Mitologia):
divinità romana identificabile con il dio greco Hermes (v.) e con l'etrusco Turms. Era
considerato protettore dei commercianti e dei ladri, custode delle porte delle abitazioni,
nonché messaggero degli dei dell'Olimpo e psicopompo (accompagnatore delle anime fino
alla barca di Caronte). L'antica Grecia lo assimilava all'egizio Thoth (v.), ministro di
Osiride, inventore delle misure, dei geroglifici e portatore di abbondanza e di ricchezza.
Era raffigurato con le ali alle calcagna e sul petaso, impugnante il caduceo con
intrecciati due serpenti, simbolo poi delle arti mediche e farmaceutiche. y (Astronomia): è il pianeta più piccolo del sistema
solare ed il più vicino al Sole, avendo 88 giorni di rivoluzione siderale e 59 di
rotazione. La sua temperatura varia da 0° nell'oscurità ai 340° nella zona illuminata. y (Chimica): elemento chimico con simbolo "Hg".Viene
ricavato soprattutto dal suo solfuro (HgS), denominato cinabro, ed è un metallo argenteo,
liquido a temperatura ambiente, base degli amalgami. Trova largo impiego in diverse
attività industriali. y (Alchimia): Il M. è il più
importante tra i segni alchemici - I -, in
quanto sintetizza l'intera dottrina ermetica. Il Wirth afferma che non si è lontani dal
possedere il segreto della Grande Arte, quando si è riusciti a discernere quello che i
filosofi hanno velato sotto il suo simbolo. La semplice analisi del suo ideogramma
evidenzia il segno di Venere sormontato dalla Luna crescente, oppure il segno del Sale
Alkali con l'aggiunta della croce. Nel primo caso, Venere indica una sostanza
contenente energie vitali destinate a dispiegarsi, mentre la Luna crescente denota
un'evoluzione prodotta nel dominio sublunare, ovvero nella sfera della materialità
soggetta a perpetui cambiamenti. Il M. rappresenta quindi l'essenza fondamentale della
vita delle cose, come il principio grazie al quale esse nascono, si sviluppano e si
trasformano. Nel secondo caso il Sale Alkali, o materia prima dei Saggi, potenzialmente
atta a subire ogni metamorfosi, viene radicalmente mutato dall'aggiunta della croce,
indice di fecondazione. Viene così animata da questa liberazione generatrice di vita,
facendole realizzare le sue latenti potenzialità. I filosofi ermetici hanno usato diversi
termini per designare il loro M., privilegiando però l'Azoto. Veniva scritto AZW t, così da risultare cabalisticamente
dall'iniziale comune a tutti gli alfabeti (A), seguita dall'ultima lettera latina (Z),
greca (W ) ed ebraica (t)),
rappresentando l'Azoto l'inizio e la fine contemporanea di ogni corpo. Rovesciato, il
simbolo del M. ricalca lo schema del 3° Arcano dei Tarocchi, raffigurante l'Imperatrice,
la Regina dei cieli e la Vergine alata dell'Apocalisse. L'analisi di quest'ideogramma
rivela la presenza dell'Antimonio dominatore della Luna decrescente. Insomma, non si
tratta più dell'Anima delle cose o della vitalità, ma dell'Anima celeste, che libera
dalla materia, elevando e spiritualizzando l'essere umano. Occorre notare che ci troviamo
nel dominio dell'universalità, ovvero nelle sfere più alte del pensiero che governa il
Creato. Infine, nella sua qualità di mediatore universale, il M. fa da collegamento con
gli altri metalli o pianeti, senza evidenziare alcuna affinità con questi. Di qui il suo
carattere neutro od androgino, che lo conferma partecipe di tutte le qualità.
Mercurio: (Mitologia):
divinità romana identificabile con il dio greco Hermes (v.) e con l'etrusco Turms. Era
considerato protettore dei commercianti e dei ladri, custode delle porte delle abitazioni,
nonché messaggero degli dei dell'Olimpo e psicopompo (accompagnatore delle anime fino
alla barca di Caronte). L'antica Grecia lo assimilava all'egizio Thoth (v.), ministro di
Osiride, inventore delle misure, dei geroglifici e portatore di abbondanza e di ricchezza.
Era raffigurato con le ali alle calcagna e sul petaso, impugnante il caduceo con
intrecciati due serpenti, simbolo poi delle arti mediche e farmaceutiche. y (Astronomia): è il pianeta più piccolo del sistema
solare ed il più vicino al Sole, avendo 88 giorni di rivoluzione siderale e 59 di
rotazione. La sua temperatura varia da 0° nell'oscurità ai 340° nella zona illuminata. y (Chimica): elemento chimico con simbolo "Hg".Viene
ricavato soprattutto dal suo solfuro (HgS), denominato cinabro, ed è un metallo argenteo,
liquido a temperatura ambiente, base degli amalgami. Trova largo impiego in diverse
attività industriali. y (Alchimia): Il M. è il più
importante tra i segni alchemici - I -, in
quanto sintetizza l'intera dottrina ermetica. Il Wirth afferma che non si è lontani dal
possedere il segreto della Grande Arte, quando si è riusciti a discernere quello che i
filosofi hanno velato sotto il suo simbolo. La semplice analisi del suo ideogramma
evidenzia il segno di Venere sormontato dalla Luna crescente, oppure il segno del Sale
Alkali con l'aggiunta della croce. Nel primo caso, Venere indica una sostanza
contenente energie vitali destinate a dispiegarsi, mentre la Luna crescente denota
un'evoluzione prodotta nel dominio sublunare, ovvero nella sfera della materialità
soggetta a perpetui cambiamenti. Il M. rappresenta quindi l'essenza fondamentale della
vita delle cose, come il principio grazie al quale esse nascono, si sviluppano e si
trasformano. Nel secondo caso il Sale Alkali, o materia prima dei Saggi, potenzialmente
atta a subire ogni metamorfosi, viene radicalmente mutato dall'aggiunta della croce,
indice di fecondazione. Viene così animata da questa liberazione generatrice di vita,
facendole realizzare le sue latenti potenzialità. I filosofi ermetici hanno usato diversi
termini per designare il loro M., privilegiando però l'Azoto. Veniva scritto AZW t, così da risultare cabalisticamente
dall'iniziale comune a tutti gli alfabeti (A), seguita dall'ultima lettera latina (Z),
greca (W ) ed ebraica (t)),
rappresentando l'Azoto l'inizio e la fine contemporanea di ogni corpo. Rovesciato, il
simbolo del M. ricalca lo schema del 3° Arcano dei Tarocchi, raffigurante l'Imperatrice,
la Regina dei cieli e la Vergine alata dell'Apocalisse. L'analisi di quest'ideogramma
rivela la presenza dell'Antimonio dominatore della Luna decrescente. Insomma, non si
tratta più dell'Anima delle cose o della vitalità, ma dell'Anima celeste, che libera
dalla materia, elevando e spiritualizzando l'essere umano. Occorre notare che ci troviamo
nel dominio dell'universalità, ovvero nelle sfere più alte del pensiero che governa il
Creato. Infine, nella sua qualità di mediatore universale, il M. fa da collegamento con
gli altri metalli o pianeti, senza evidenziare alcuna affinità con questi. Di qui il suo
carattere neutro od androgino, che lo conferma partecipe di tutte le qualità.
Merovingi: Dinastia
di sovrani franchi, il cui capostipite fu Meroveo (m. 457 ca.) che, salito al trono con il
fratello Clodio, combatté contro gli Unni a fianco del generale romano Ezio, ed estese il
suo potere alla Gallia settentrionale ed alla Gallia Belgica meridionale. Verso la fine
del V secolo i M., sotto il re Clodoveo, sconfissero ed assoggettarono tutte le altre
dinastie franche, unificando sotto il proprio scettro l’intera popolazione.
L’espansione M. continuò sotto i figli di Clodoveo, che conquistarono quasi tutta la
Gallia, arrestati a meridione solo dai Visigoti. Respinti nei loro tentativi di
penetrazione verso la Spagna e l’Italia, i M. poterono ampliare i propri confini ad
oriente, superando il Reno ed annettendo la Turingia. L’uso di spartire i territori
fra gli eredi, portò a gravi conseguenze. Il frazionamento del regno ne corrose così la
struttura del regno, indebolendo il potere centrale a vantaggio di un’aristocrazia
sempre più invadente, mentre le lotte interne, spesso cruente, smembravano lentamente uno
stato già poco incline all’unità. Alla fine del VII secolo l’autorità sovrana
era praticamente annullata, tanto da aprire la strada all’intraprendenza della nuova
dinastia nascente dei Carolingi, che con Pipino il Breve assumeva i poteri sovrani (751).
Mesmer
Franz Anton: Il tedesco di Costanza Franz Anton
Mesmer (1734-1815) si era laureato in filosofia ed in medicina (1766) presso
l’università di Vienna. Fin dalla dissertazione "De Planetarum influxu in
corpus humanum" con cui conseguiva la laurea in medicina, sosteneva le sue teorie sul magnetismo naturale di origine minerale, capace di agire sugli organismi viventi, più tardi trasformato in magnetismo animale. Si tratta di una medicina alternativa molto simile alla pranoterapia, che M. passava ben presto a praticare ai suoi pazienti. Egli applicava lievemente le mani aperte sul paziente, dall’alto al basso del loro corpo, o mettendosi in contatto con sostanze sulle quali aveva effettuato le stesse operazioni. I pazienti si sentivano presi da sonnolenza, da crampi, e denunciavano strane sensazioni, ma parecchi guarivano.  Il metodo terapeutico adottato da M. suscitò notevole scalpore, incontrando la netta opposizione dell’ambiente scientifico e religioso di Vienna, per cui fu costretto a trasferirsi a Parigi (1778), dove ottenne fama e successo. Il metodo di M., noto come mesmerismo (v.), indubbiamente soggetto a suggestioni ed
abusi, nelle sue linee fondamentali è decisamente credibile, in quanto si tratta di una
terapia ancorata all’eterico, ovvero al campo delle linee di forza plasmatrice che
sostiene l’organismo ed il suo funzionamento. Esso è tradizionalmente inquadrato
nella medicina romantica di fine settecento, e rappresenta un'anticipazione delle moderne
posizioni dell'ipnotismo. M. aderì alla Massoneria, essendo accertato che sia stato
membro della Loggia esoterica dei Philadelphi di Narbonne.
Il metodo terapeutico adottato da M. suscitò notevole scalpore, incontrando la netta opposizione dell’ambiente scientifico e religioso di Vienna, per cui fu costretto a trasferirsi a Parigi (1778), dove ottenne fama e successo. Il metodo di M., noto come mesmerismo (v.), indubbiamente soggetto a suggestioni ed
abusi, nelle sue linee fondamentali è decisamente credibile, in quanto si tratta di una
terapia ancorata all’eterico, ovvero al campo delle linee di forza plasmatrice che
sostiene l’organismo ed il suo funzionamento. Esso è tradizionalmente inquadrato
nella medicina romantica di fine settecento, e rappresenta un'anticipazione delle moderne
posizioni dell'ipnotismo. M. aderì alla Massoneria, essendo accertato che sia stato
membro della Loggia esoterica dei Philadelphi di Narbonne.
Mesmerismo: Cura delle malattie con il magnetismo animale, secondo il metodo ideato dal
medico tedesco Franz Anton Mesmer (1734-1815) fin dalla dissertazione "De
Planetarum influxu in corpus humanum" con cui conseguiva nel 1766 la laurea in
medicina presso l'università di Vienna. Implica la presenza di un magnetismo naturale di
origine minerale, capace di agire sugli organismi viventi. Alla base c'era una dottrina
particolare, decisamente contrastata sia dalla scienza che dalle autorità religiose. Il
metodo è inquadrato nella medicina romantica di fine settecento, e rappresenta
un'anticipazione delle moderne posizioni dell'ipnotismo (v. ipnosi). Grande seguace del M.
fu Samuel F.C. Hahnemann (1755-1843), padre della medicina omeopatica, fondata sul
concetto di analogia, iniziato nel 1777 in una Loggia di Hermanstadt ed affiliato nel 1817
alla Loggia Minerva di Lipsia. Questi, nella sua opera "Omoeopatia, Organon
dell’Arte del guarire", espresse idee decisamente famigliari ad ogni Libero
Muratore, come risulta evidente nella prefazione all’edizione del 1810: "È
opportuno insistere fin dall’inizio sull’indolenza, la negligenza e
l’ostinazione, tre gravi difetti la cui presenza esclude qualsiasi possibilità di
porsi al sacro servizio della Verità. Soltanto l’uomo privo di pregiudizi ed armato
di intrepido zelo, può esprimere questa vocazione, la più sacra di tutte,
nell’esercizio della vera Arte del guarire. Il maestro di una tale arte, aiutando le
creature dell’Onnipotente a mantenersi in salute ed in vita, sconfina quasi nel
divino, avvicinandosi così al Creatore Supremo, la cui benedizione, compiuto il proprio
dovere, rende il suo cuore colmo di felicità". Più oltre, definendo nella stessa
opera il principio vitale dell’uomo, Hahnemann propone un’idea di finalismo
corporeo imbevuta di concetti latomistici di ragione, armonia ed elevazione: "Nello
stato di salute, l’energia vitale sovrana ed immateriale, la Dynamis, che
anima la componente materiale dell’organismo umano, regna in maniera assoluta. Fra
tutte le componenti dell’organismo vivente impegnate delle diverse attività
funzionali e reattive, essa mantiene un’armonia che induce all’ammirazione. Lo
spirito dotato di ragione, presente nell’organismo, può così servirsi liberamente
di questo strumento sano e vivo nel tendere verso il fine elevato della propria
esistenza" (Nuova Enciclopedia Massonica, di M. Miramarco, Vol.II, Ediz.
C.E.S.A.S. 1989, pag. 268)
Mesora: Termine ebraico
(anche Messora) dal significato di tradizione, indica il complesso del lavoro
critico compiuti nei diversi periodi storici tra il IV e l’XI secolo da studiosi
ebraici per stabilire lo stato autentico e primitivo dei testi dei Libri dell’Antico
Testamento che sono ritenuti sacri. I testi riveduti vengono denominati massoretici,
mentre sono definiti punti massoretici i punti indicanti le doppie consonanti
nell’ortografia ebraica, introdotti per fissare l’esatta pronuncia.
Messa: Cerimonia
liturgica cristiana cattolica ed ortodossa, rappresentante la celebrazione ed il
rinnovamento del sacrificio di Gesù sulla croce, durante la quale il sacerdote offre a
Dio il corpo ed il sangue dello stesso Gesù, sotto la specie del pane e del vino. La M.
come ripetizione del sacrificio di Gesù è stata negata prima dagli Albigesi (XIII
secolo), poi da Wycliff (XV secolo), quindi in generale dai Protestanti, che le
attribuiscono solo valore di ricordo dell’ultima cena del Signore. Tuttavia il
Concilio di Trento (XXII sessione) ha ribadito la realtà della M. nel senso cattolico
attuale. La M. è nata nelle pie riunioni dei cristiani primitivi (v. agapi), nel
corso delle quali, sulle linee del rituale della pasqua ebraica, si recitavano preghiere e
salmi per finire con il compimento del rito eucaristico (v. Eucarestia). Vi anche le
riunioni notturne (vigiliae), analoghe a quelle giudaiche nella sinagoga: oltre al
canto di inni ed alla recitazione dei salmi, vi si leggevano i Vangeli e delle epistole
paoline, e si ascoltava la predicazione dell’episcopo (o vescovo). La M. latina si
divide in due parti: M. dei catecumeni (nella chiesa primitiva i non battezzati
venivano allontanati all’offertorio), e M. dei fedeli. La distinzione tra le
due parti risale essenzialmente al II secolo: ufficiatura delle letture divine e
celebrazione del sacrificio; in seguito vennero introdotti anche elementi di origine
romana e gallicana. La prima parte della M. comprende: saluto ai fedeli, preghiere
preparatorie (dal IX secolo), confiteor (dal XII secolo), introito, kyrie, gloria,
colletta, due letture (dall’Antico Testamento e dalle epistole paoline), graduale,
tratto, sequenza, vangelo (dal VI secolo per l’Oriente, dall’XI per Roma),
predica e credo; la seconda parte comprende: offertorio, secreta (dal XIV secolo),
prefazio, sanctus, canone (dal VII secolo9 con consacrazione (pane azzimo dal IX secolo,
ostia dal XII), dossologia, Pater noster, augurio di pace, Agnus Dei, comunione (sotto le
due specie), postcommunio, benedizione ed ite missa est. Più tardi (XV secolo)
vennero aggiunte la lettura dell’inizio del Vangelo di Giovanni ed altre preghiere.
Dopo il concilio ecumenico Vaticano II (1963), le parti della M. vengono pronunciate nella
lingua nazionale dei vari popoli (riforma del 1970). La recitazione dei testi della M.,
che provengono quasi interamente dalla Bibbia e sono contenuti nel messale, viene
accompagnata da minuziose cerimonie (segni di croce, inchini e genuflessioni)
espressamente indicate dalle rubriche (parti scritte in rosso) nel messale stesso.
Il celebrante deve indossare i paramenti liturgici (amitto, camice, cingolo, stola,
manipolo e pianeta), con colori diversi secondo le ricorrenze, ed essere digiuno da almeno
tre ore. Inoltre l’altare, che contiene la pietra santa, comprende tre tovaglie, una
croce, calice con patena, corporale, purificatore, borsa, palla, ostia, vino ed acqua in
ampolle, messale e campanello. Nella M. la musica assunse sempre grandissima importanza,
poiché diverse testimonianze dimostrano che fin dall’inizio dell’organizzazione
liturgica varie parti venivano cantate. I Graduali, che raccolgono l’intero
patrimonio delle M. gregoriane divise nelle due parti principali (Proprium Missae ed
Ordinarium Missae), sono una testimonianza imponente attribuita alla musica nella
M. fino al XII secolo. Con il sorgere della polifonia, anche varie parti della M. vennero
composte a due o più voci, generalmente basandosi su una melodia gregoriana. Intorno al
XIV secolo l’interesse dei compositori si orientò verso l’Ordinarium, che ben
presto divenne l’unica parte cantata della M. nel Seicento lo stile a cappella lascia
il posto a quello concertato, cioè con dialogo fra voci e strumenti, e fra voci soliste e
coro. Esempio sommo di questo stile è rappresentato dalla Messa in si minore (1733) di
Bach, unico accostamento del grande luterano alla liturgia cattolica. Alla fine del secolo
si hanno anche notevoli esempi in Mozart (Missa in honorem SS. Trinitatis, 1773; Krönungsmesse,
1779; Requiem, (1791). Ma ormai la M. tende a diventare un fatto musicale a sé
stante, senza alcun rapporto con la liturgia, e nasce la M. concerto. Sono tipiche le
grandi M. romantiche, come il Requiem di Cherubini (1816), la Missa solemnis
di Beethoven (1819-23), la Messa di Gran di Liszt (1855), La petite Messe
solemnelle di Rossini (1863), il Requiem di Verdi (1874), la Messa di
Stravinski (1948). Discorso a parte meritano le M. per organo, affidate esclusivamente a
questo strumento, illuminato dalle creazioni di Girolamo Cavazzoni, Claudio Merulo,
Frescobaldi, Andrea Gabrieli, Froberger, Bach, Couperin, Liszt. Satie e Messiaen.
Messale: Termina con il
quale si identifica il libro contenente, per ciascuna giornata dell’anno liturgico,
preghiere, letture e canti per la celebrazione della messa (v.), e che assomma in sé gli
antichi Sacramentari, Graduali ed Evangeliari. A seconda del rito, assume in nome di M.
romano, ambrosiano o mozarabico. I primi esempi di M. completi risalgono al VII secolo, ma
gli esemplari più interessanti, finemente e riccamente miniati, si hanno a partire dal IX
secolo. Tra questi importanti sono il Missale bobbiense del X secolo (Biblioteca
Ambrosiana di Milano), il M. di Gian Galeazzo del 1370 (Chiesa di
Sant’Ambrogio, Milano), il Missale Ambrosianum del XIV secolo (Biblioteca
Ambrosiana, Milano), il M. di Mattia Corvino del 1490 (Biblioteca Vaticana, Roma),
il M. di Borso ed il Missale romanum (Biblioteca Trivulziana, Milano)
entrambi del XV secolo.
Messaliani: Setta
ascetica cristiana dell’Asia Minore (metà IV secolo) diffusasi dalla Mesopotania in
Siria, Armenia ed Egitto. Denominati anche massaliani, euchiti od eufemiti, i M.
conducevano una vita solitaria o cenobitica, dedita esclusivamente alla preghiera, la sola
pratica (sostenevano) capace di scacciare il diavolo che ogni essere umano porta in sé,
come conseguenza del peccato originale, peccato che non verrebbe allontanato nemmeno
attraverso il battesimo. Tale tesi eretica venne condannata durante il sinodo di Side, in
Panfilia (390) ed il concilio di Efeso (431). I M. sopravvissero fino al X secolo, ed
influenzarono il sufismo (v.) musulmano.
Messia: Dall’ebraico
masiah, unto, è un termine usato nell’Antico Testamento quale attributo dei
re o del sommo sacerdote, in quanto unti dal Signore (I Samuele 10, 1; 16,
13; ecc.). Secondo i Profeti, il M. è inviato da Dio per realizzare un’epoca di
felicità per Israele, ed il trionfo definitivo della religione di Jahweh (Isaia 8,
1-7). In epoca postesilica (dopo Mosé) la missione del M. assume carattere essenzialmente
nazionale, di ristabilimento della libertà di Israele, e determina la corrente religiosa
del messianesimo (v:). Secondo le scuole rabbiniche, il M., discendente di Davide,
sarà preceduto dal profeta Elia, e riporterà gli Ebrei nella loro terra, realizzando un
rinnovamento dell’umanità in un’epoca di prosperità, pace e felicità
universale. Nel giudaismo moderno non ortodosso il M. è identificato con un’idea di
giustizia universale. Nel Nuovo Testamento Gesù Cristo è considerato M., discendente del
re Davide. Gli si riferiscono passi vetero-testamentari, come Genesi 3, 14 ss.; 9,
25 ss.; 12,1 ss.; Salmi 2, nonché 6 ed 8; Isaia 11, 1 s.; soprattutto
49-57.
Messianesimo: Detto
anche Messianismo, definisce una corrente religiosa ebraica, caratterizzata dalla
aspettazione e dalla speranza in un futuro di felicità e di gloria, quando Dio
realizzerà la propria opera di riscatto attraverso l’intervento di un suo inviato,
il Messia (v.), e l’instaurazione del suo potere supremo nel mondo (Regno
di Dio). Durante l’antico regno ebraico, la figura del Messia si sviluppa in
netto contrasto con i successori di Davide: così l’empietà di Achaz (II Re
16, 2 ss.) dà al profeta Isaia l’occasione di annunciare un Messia in rapporti di
intimità con Dio (Isaia 2, 4); le disillusioni del ritorno dall’esilio sono
compensate dalla visione di una Gerusalemme futura illuminata dalla gloria del Messia (Isaia
69, 7). Con la dominazione persiana (539-531 a.C.) il vero M. sembra accantonato, mentre
le speranze in un avvenire migliore vengono riportate ad una specie di acceso
nazionalismo, che si prospetta nell’instaurazione del Regno di Dio senza
alcuna mediazione. Durante la persecuzione di Antioco IV Epifane, (168-167 a.C.)
s’incomincia a concepire un regno dove Dio riunisce tutti quelli che avranno avuto
fede in Lui: questo regno è dominato da un personaggio enigmatico, "simile ad un
figlio dell’uomo", il quale riceve la sua investitura direttamente da Dio.
La letteratura giudaica extrabiblica e postbiblica (Enoch, IV Esedra) adotta
un nuovo genere letterario, l’apocalisse, già utilizzato dall’autore di Daniele
(7, 13-14): il Messia guida la lotta contro le potenze del Male, e la sua vittoria finale
viene associata alla resurrezione del genere umano, al giudizio finale ed alla successiva
instaurazione del nuovo mondo, con una nuova Genesi ed un nuovo Patto. Gli Apostoli ed i
primi cristiani credettero che la resurrezione di Gesù Cristo (v.) provasse la verità
delle sue affermazioni: egli era cioè il Messia atteso e, proprio con la sua comparsa,
cominciano a realizzarsi i tempi messianici. Allo stesso modo, altri testi vetero
testamentari vengono interpretati ad usum evangelii: Gesù, nato dalla vergine
Maria, corrisponde all’annuncio della vergine che avrebbe partorito il Messia (Isaia
9, 1-6; 11, 1-9); la nascita di Gesù a Betlemme è stata annunciata da Michea (5,
1-5); il regno del Messia viene descritto nei Salmi (22, 30 ss.); il suo sacerdote
ancora nei Salmi (110); la passione di Gesù, annunciata in Isaia, mostra che il Messia
instaurerà un regno in cui la sofferenza avrà il primo posto e la gloria umana non
potrà essere accolta. L’elemento di trascendenza insito nel M. trova la sua massima
espressione nel supremo atto di fede: Gesù Cristo è "figlio di Dio".
Anche se molti sacerdoti ebrei aderirono alla fede cristiana (Atti 6, 7), la massa
del popolo si rifiutò di credere in Gesù, e continuò ad attendere la venuta di un
Messia. Fra i più celebri rappresentanti del nuovo M. vi fu Bar Kokheba, capo della
seconda rivolta giudaica (132-135 d.C.). Alcuni messia vennero riconosciuti nel corso dei
secoli: Abraham Abulafia di Saragozza (XIII secolo); Dawid Re’ubeni (XVI secolo);
Shabbetay sebi (XVII secolo) e Ya’aqob Frank (XVIII secolo). Anche la liturgia
giudaica attuale è tutta pervasa dall’attesa messianica. Per estensione si dice M.
anche ogni tipo di dottrina ed ideologia che susciti negli adepti una sorta d’attesa
escatologica, analoga al M. propriamente detto.
Messianico: Termine
con il quale viene definito quanto attinente la figura profetica, carismatica e divina del
Messia.
Metafisica: Oltre le cose fisiche. È la parte della filosofia che perviene alla spiegazione dei principi essenziali della realtà procedendo oltre i dati dell'esperienza. Il termine, coniato dal filosofo greco Andronico da Rodi nel primo secolo a.C., trae origine dal fatto che nella prima edizione delle opere di Aristotele i libri di ontologia (v.) erano disposti dopo i trattati di fisica. Spregiativamente indica una cosa astrusa, di difficile comprensione, oppure cosa astratta, assurda, falsa, priva di ogni rapporto con la realtà concreta. Secondo lo stesso Aristotele M. significa scienza che studia i principi e le cause, l'essere in quanto tale con le sue proprietà, la sostanza delle cose, l'Essere Supremo e la sostanza soprasensibile. È una scienza teoretica, non volta a fini pratici, quindi è ricerca per se stessa, e per l'uomo rappresenta la massima fonte di perfezione e felicità. Per san Tommaso d'Aquino le caratteristiche della M. sono sei: 1) è aperta a tutto lo scibile, poiché i suoi principi universali influenzano l'intero sapere umano; 2) tratta i problemi più elevati e complessi, poiché astratti dai sensi e dalla materia; 3) porta a maggiori certezze, in quanto ha origine da principi assolutamente certi; 4) è la più dottrinale delle scienze, perché indaga sulle cause più universali e profonde della realtà; 5) e la più intellettuale di tutte le scienze, poiché il suo campo conoscitivo è il più puro ed elevato; 6) conseguentemente è regolatrice e direttrice di ogni scienza, in funzione del suo altissimo fine, il quale è la prima causa che muove tutte le altre, da cui dipende il conoscere, l'agire ed il fare delle scienze e delle arti. (v.
Testi filosofici scelti ed annotati, di Tommaso d'Aquino, Ediz. Nardi, Bari, 1915).
Metafora: Dal greco metafora, trasferimento, è una figura retorica consistente
nella trasposizione di un termine dal concetto cui propriamente si applica ad un altro che
ha qualche somiglianza caratteriale con il primo. Aristotele (v.) studiò e classificò i
generi di M., indicandone la peculiare funzione estetica nella poesia drammatica. Il Vico
riconobbe l'origine metaforica di tutto il linguaggio, e tale teoria venne sviluppata
nell'estetica romantica e dalle poetiche successive (v. simbolismo). Un esempio
chiarificatore del concetto è rappresentato da un individuo agile di cui si dice che è
uno scoiattolo, mentre di uno veloce che è una lepre.
Metalli dei Saggi: Secondo la tradizione alchemica essi sono due, ovvero: ·
1) Argento dei Saggi: viene anche definito "Mercurio dei saggi",
in opposizione al Mercurio Filosofico che lo precede nello stadio precedente, e che non
bisogna confondere con il Mercurio dei folli, ovvero l’argento vivo volgare.
L’Argento dei saggi, od Argento Filosofico, è il composto risultante
dall’assorbimento di una quantità proporzionata di oro volgare e da una quantità
determinata di Mercurio principio. Questo oro volgare non deve aver subito alcuna
precedente fusione o combinazione, ovvero dev’essere vergine. ·
2) Oro dei Saggi: chiamato anche "Zolfo dei Saggi", in opposizione
allo Zolfo dei Filosofi che lo precede allo stadio precedente, od allo Zolfo dei folli o
volgare. L’Oro dei saggi, od Oro Filosofico, risulta composto dall’assorbimento
di una quantità proporzionale di argento volgare da parte di una determinata quantità di
zolfo principio. L’argento volgare impiegato dev’essere puro e vergine, ovvero
mai fuso precedentemente né comunque miscelato o trasfuso. Queste due operazioni
risultano da una serie di Cotture successive (reiterazioni oppure coobazioni,
termini alchemici indicanti il ripetersi successivo di una data operazione) effettuate
sempre nell’apposito crogiolo, detto Athanor.
Metalli: Termine con
cui vengono indicati elementi chimici caratterizzati da diverse proprietà fisiche e
chimiche qualitativamente simili. Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, i M.,
con la sola eccezione del Mercurio che è allo stato fluido a temperatura ambiente, sono
tutti solidi, con temperature di fusione comprese tra 30°C. (gallio e cesio) e 3410 °C.
(tungsteno). Presentano un caratteristico splendore (definito metallico), con colorazioni
varianti dal bianco (argento) al grigio bluastro (piombo), e sono opachi. Le loro
proprietà sono la tenacità, l'elasticità, la plasticità, la fragilità, la
malleabilità, la durezza, la fusibilità, la volatilità, la conducibilità
elettro-termica e le caratteristiche magnetiche. Y (Massoneria)
L’espressione viene usata nei due sensi letterale e figurato. All’iniziando viene chiesto di spogliarsi dei M., ovvero denaro, gioielli ed oggetti metallici. È un atto liberatorio ed eloquente, in quanto insegna che tutto si paga in questo mondo, e che non si può sperare di ricevere senz’aver prima dato. Tale spoliazione simboleggia l’abbandono dell’attaccamento alle idee preconcette. Il profano deve sforzarsi di pensare da solo, e non conservare una viva dipendenza dai pensieri più piacevoli fino ad allora dominanti in lui (Geralde). Secondo Leadbeater, "Il
candidato deve togliersi tutti i M. perché questi impediscono la circolazione delle
correnti sottili". Per il Boucher, "I M. sono impuri,
un’opinione risalente all’età della pietra, quando già era consentito offrire
sacrifici o compiere il rito della circoncisione solo usando un coltello di pietra".
Prima di accedere al Tempio e partecipare ai Lavori Rituali, ogni Massone deve spogliarsi
dei M., ovvero deve abbandonare l’assordante loro rumore ed il loro pesante
influsso, che nella profanità lo condizionano limitandolo, liberandosi anche delle passioni,
che dei M. sono la conseguenza. Senza questo fondamentale atto preliminare, l’accesso
al Tempio diventa una vera e propria profanazione. Y
(G.O.I.) I simboli sono trasposizioni analogiche di concetti comuni. Così, nel caso
dei M., si prendono in considerazione alcune delle loro proprietà fisiche per proporne
altre analoghe, che si riferiscono a stati e modi di essere che non hanno però niente di
materiale. I M. sono più o meno facilmente plasmabili dall'artista, resistono in analoga
misura alle deformazioni esercitate dall'esterno, presentano caratteristiche diverse di
inossidabilità. Si presentano infine con un contenuto non sempre esente da impurità.
Perciò si prestano molto bene a rappresentare gli aspetti della forma del nostro
personale Microcosmo. Nella produzione dei nostri simbolici metalli, puri o impuri che
siano, gli artefici sono due: l'artista, all'interno del Microcosmo, e l'influenza del
Macrocosmo tramite gli eventi. Tuttavia, i M. rappresentano sempre una forma del
Microcosmo, della quale siamo in ogni caso responsabili, sia che si operi attivamente da
artisti che passivamente da ricettori di eventi. Secondo la Tradizione massonica tutti i
M., simbolicamente rappresentativi della materia, del mondo profano e delle passioni,
debbono essere sempre lasciati al di fuori del Tempio.
Metamorfosi: Dal
greco meta, indicante mutamento e morfh,
forma, ovvero cambiamento di forma. Trasformazione di un essere in un altro. Termine molto
usato in zoologia, indicante le trasformazioni morfologiche e fisiologiche che si
verificano in molti gruppi zoologici durante lo sviluppo postembrionale, ossia dalla
nascita, intesa come fuoruscita dell'uovo, al momento della maturità sessuale. La M. è
caratteristica di tutti gli animali a sviluppo indiretto, e comporta profonde
ristrutturazioni di tutta l'organizzazione dell'organismo. Il meccanismo fisiologico della
M. è diretto da ghiandole endocrine o da porzioni del sistema nervoso, che sono in grado
di produrre secrezioni interne. Comporta la regressione di organi larvali e l'insorgenza
di nuove strutture. Nel caso degli anfibi si ha la completa scomparsa delle branchie e la
completa formazione dei polmoni e di una superficie cutanea in grado di stabilire scambi
respiratori. Y (Mitologia) Nella mitologia classica, con
M. si intende la trasformazione, temporanea o definitiva (per effetto dell'intervento di
un dio o in forza di magia, sia per punizione sia per premio), di un essere umano o divino
in un altro essere di diversa natura (animale, vegetale o minerale). Fra le M. temporanee
le più famose sono quelle di Zeus in toro, cigno, aquila, pioggia aurea, ecc. Altre
celebri M. quelle di Dafne in alloro, di Narciso e di Giacinto nei fiori omonimi, di Niobe
in pietra, di Aracne in ragno, di era in nube, di Atteone in cervo, di Progne in rondine,
di Filomena in usignolo, di Tereo in upupa, di Licarne in lupo, ecc. La maggior parte
delle M. classiche sono state raccolte da Ovidio nelle sue celebri M.
Metapsichica: Termine
derivato dal greco meta (oltre) e fuch (anima), introdotto nel 1905 da C.R. Richet per indicare lo studio dei
fenomeni psichici che superano la normale conoscenza umana: telepatia, medianità,
preveggenza o charoveggenza, percezione extrasensoriale, telecinesi, levitazione, ecc.
Attualmente tali fenomeni vengono accomunati sotto la denominazione di parapsicologia (v.).
Metempsicosi: Dottrina
religiosa filosofica che ammette il passaggio dell'anima di corpo in corpo, dal mondo
minerale a quello vegetale, poi a quello animale per finire all'umano. Si tratta di una
credenza antichissima, di cui si trovano tracce sia nel mondo indiano (induismo) sia
in Egitto, sia nel mondo Greco antico (Orfismo, Pitagora e sette pitagoriche, Empedocle).
La M. è sempre collegata a credenze di tipo morale sul destino etico individuale, e viene
spesso inserita in una visione cosmogonica e naturalistica generale (v. Reincarnazione).
Platone opera una purificazione di tale dottrina, sia in Fedro (249) che in Repubblica
(10, 614), collegandola alla teorie delle idee e dei rapporti tra corpo corruttibile e
verità eterne. In tale forma la M. si trasferisce nel pensiero gnostico, dove al
tradizionale significato morale ed -espiatorio se ne aggiunge uno conoscitivo. La M. si
trova anche al centro delle teorie teosofiche.
Metodi del G.O.I.: Il Grande Oriente d’Italia: · lavora alla Gloria
del Grande Architetto dell’Universo; · osserva gli
Antichi Doveri, usi e costumi dell’Ordine; · adotta i
rituali conformi alla Tradizione muratoria; · apre il Libro
della Sacra Legge sull’Ara del Tempio, e vi sovrappone la Squadra ed il Compasso; · segue il simbolismo nell’insegnamento e l’esoterismo
nell’Arte Reale; · applica la distinzione della
Massoneria nei tre Gradi di Apprendista, Compagno d’Arte e Maestro; · insegna la leggenda del terzo Grado; ·
non tratta questioni di politica e di religione; · inizia
solamente uomini che siano liberi e di buoni costumi, senza distinzione di razza,
cittadinanza, censo, opinioni politiche o religiose (Gran Loggia del 19-20 Marzo 1994
– Art. 5 della Costituzione dell’Ordine).
Metodi della Gran Loggia: La Gran Loggia si riunisce una volta all'anno all'Equinozio di Primavera, lavora
nel Grado di Maestro, e può essere convocata in sessione straordinaria anche in epoca
diversa. La Gran Loggia (v.) è validamente costituita quando siano presenti la metà più
uno dei rappresentanti delle Logge aventi diritto di voto. Per modificare la Costituzione
ed il Regolamento dell'Ordine è necessaria la presenza dei due terzi dei Rappresentanti
delle Logge aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti
(Art. 18 della Costituzione del Grande Oriente d’Italia).
Metodi della Giunta: La Giunta del Grande Oriente d'Italia si riunisce in sedute ordinarie nei giorni
da essa stabiliti; in caso di urgenza, il Gran Maestro può convocarla in seduta
straordinaria. Le sedute sono valide quando siano presenti almeno cinque Membri Effettivi;
le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità di voti, prevale il voto di
chi presiede (Art. 37 della Costituzione dell'Ordine).
Metodi della Loggia: La Loggia si riunisce sotto la guida del Maestro Venerabile, e lavora nei tre
Gradi di Apprendista, Compagno d'Arte e Maestro, in conformità dei rituali approvati
dalla Gran Loggia, e con la presenza di almeno cinque Fratelli Maestri. La Loggia
può adottare un proprio Regolamento interno, le cui norme non debbono essere in contrasto
con la Costituzione ed il Regolamento dell'Ordine. Il Regolamento dell'Ordine determina le
procedure della costituzione, della fusione, dello scioglimento, della sospensione,
dell'estinzione e della demolizione delle Logge. Regola inoltre le modalità di
svolgimento dei Lavori, e le maggioranze necessarie per l'adozione delle deliberazioni
(Art. 18 della Costituzione del Grande oriente d’Italia).
Metodismo: Movimento
evangelico di risveglio religioso iniziato nel XVIII secolo nell’ambito della chiesa
anglicana, da John e Charles Wesley, e da G. Whitefield. Il movimento era diretto al
rinnovamento della coscienza religiosa contro le tendenze razionaliste del secolo, e
proponeva quindi una religiosità imperniata su un metodo di vita devota,
sull’esperienza della fede come unico mezzo di salvezza e su una forte spinta etica e
caritativa. I metodisti ammontano attualmente a circa 52 milioni, e sono particolarmente
diffusi negli Stati Uniti.
Metoscopia: Termine
derivato dal greco, avente il significato di osservazione della fronte. Indica la
capacità di predire il futuro di una persona attraverso l’esame delle rughe della
fronte. Il Cardano, nella sua opera Ars Magna del 1545, sostiene che la fronte sia, fra
tutte le parti del volto umano, la più caratteristica, e che un abile fisionomista possa
indicare con esattezza il carattere di una persona mediante la semplice osservazione della
sua fronte (v. Divinazione).
Mezzanotte: Momento
del giorno in cui l’energia, la potenza dell’astro solare è al minimo. La
Massoneria simbolicamente individua in questa precisa ora il giusto momento per porre fine
ai suoi architettonici Lavori. La M. corrisponde alla Porta degli Dei, poiché a
tale ora ha inizio il risorgere del Sole, e nei confronti della giornata corrisponde a
quello che il solstizio d’inverno rappresenta nei confronti dell’anno: il
ritorno della Luce. Considerato che il Mezzogiorno viene definito la Porta degli Uomini,
dire che il Lavoro iniziatico ha termine a M. in punto rappresenta un chiaro richiamo alla
necessità umana del riposo, all’opportunità della riflessione, al recupero delle
energie spese nelle dodici ore precedenti per l’esecuzione di tale Lavoro, con il
cammino aspro e tortuoso lungo la via iniziatica, che si è snodato dalla Porta degli
Uomini alla Porta degli Dei. La M. corrisponde quindi alla vetta, alla cima della
montagna, mentre il Mezzogiorno si identifica con la base della stessa. La M. è il
traguardo, il punto d’arrivo cui ogni iniziato tende, pur restando ben cosciente, per
confronto con l’assoluta perfezione del G\A\D\U\, della
propria imperfezione: per cui il conseguimento di tale ambita meta resta praticamente
relegato al livello di pura chimera. Un’illusione dunque, che non deve affatto
sminuire gli sforzi, le energie prodigate dallo stesso iniziato nel suo incedere lungo il
percorso della perfettibilità (v. Mezzogiorno).
Mezzo: Modo, strumento,
procedimento od altro, di cui ci si serve per raggiungere un determinato fine. Y (Massoneria.) Spesso ci sentiamo del tutto insufficienti ad affrontare con la dovuta chiarezza i grandi problemi esistenziali che si susseguono nella vita, che si presentano alla nostra coscienza sotto forma di percezioni. Una sgradevole sensazione, veramente molto comune a chi tenta di afferrare in profondità i significati, è rappresentata dal senso di sfuggevolezza di quello che si tenta di mettere a fuoco. È come se il terreno mancasse sotto i piedi. Si percepiscono cose che svaniscono appena si sposta l'attenzione su di loro. Sovente si rinuncia al tentativo, e si considerano tali percezioni senza importanza, solo perché restano razionalmente inafferrabili. Eppure, nella maggior parte dei casi, è proprio allora che potrebbero comparire alla nostra attenzione messaggi interiori degni di essere presi in attenta considerazione. La natura ci ha dotato di mezzi e di intelligenza adatti al compito proposto. È però necessario uscire dal vicolo cieco del definibile ed entrare nella sfera dell'esoterismo. Tutto questo richiede grande rigore interiore, onde almeno evitare di prendere facili abbagli. Ci vogliono anche costanza e pazienza, senza mai perdersi d'animo, senza scoraggiarsi qualora all'inizio i risultati tardassero a venire.
Mezzogiorno: Momento
del giorno in cui l’energia, la potenza dell’astro solare è al massimo. La
Massoneria simbolicamente individua in questa precisa ora il giusto momento per dare
inizio ai suoi architettonici Lavori. Taluni, come il Bacci, affermano che questa
tradizione rende omaggio al primo istitutore dei misteri, Zoroastro (v.), che riuniva
segretamente i suoi discepoli a M., rimandandoli a mezzanotte dopo aver congiuntamente
celebrato un’agape fraterna e frugale. Il M. corrisponde alla Porta degli Uomini,
poiché a tale ora ha inizio il declino del Sole, e nei confronti della giornata
corrisponde a quello che il solstizio d’estate rappresenta nei confronti
dell’anno. Considerato che la Mezzanotte viene definita la Porta degli Dei,
dire che il Lavoro iniziatico comincia a M. in punto rappresenta un chiaro richiamo al
confronto tra tale Lavoro con il cammino aspro e tortuoso lungo la via iniziatica, che si
snoda dalla Porta degli Uomini alla Porta degli Dei. Il M. corrisponde quindi alla base
della montagna, mentre la Mezzanotte si identifica con la vetta della stessa, traguardo,
punto d’arrivo cui ogni iniziato tende, pur restando assolutamente cosciente della
propria imperfezione, specie quale risultato del dovuto confronto con l’assoluta
perfezione del G\ A\ D\ U\ : per cui il conseguimento di
tale ambita meta resta praticamente relegato al livello di pura chimera. Un’illusione
dunque, che non deve affatto sminuire gli sforzi, le energie prodigate dallo stesso
iniziato nel suo incedere lungo il percorso della perfettibilità (v. Mezzanotte).
Micerino: Dal greco Muxerinoz oppure Mencerhz, nome di Mn’-k’w-r,
Menkauré, faraone egiziano della IV dinastia (2600-2480 a.C.): regnò per 16 anni
ca., succedendo al padre Chephren (v.). le vicende del suo regno sono poco conosciute:
notizie leggendarie sono state invece tramandate sia dallo storico Erodoto (v.) che da
Diodoro Siculo (1, 63). Il faraone M. si fece costruire a Gizah (v.) una piramide (quella
minore) accanto a quelle dei predecessori Cheophe e Chephren, la cui altezza è di 66,40
m. ed alla base misura 108 m. di lato. Figlio di M. fu Sepseskaf, ultimo sovrano della IV
dinastia.
Michele Arcangelo (San):
Figura dominante, unitamente a quelle di Gabriele e Raffaele,
nella folta schiera degli esseri angelici (v. Angeli) tramandataci da tradizioni
esoteriche e religioni monoteistiche. M., identificato dalla Chiesa Cattolica in
San M. viene considerato condottiero delle schiere angeliche nella lotta contro
le forze del male, ed gli è attribuita la cacciata di Lucifero e dei suoi
seguaci dalla sfera celeste. Protettore dei credenti e contrastatore della magia
nera e dei sortilegi, nel corso dei millenni gli sono stati dedicati ovunque
splendidi santuari ed imponenti cattedrali. Raffigurato bellissimo e fulgido di
luce, l'iconografia lo presenta armato, ricoperto da corazza e brandente una
spada, quella che lo vide vincitore contro il suo maggior nemico, Satana,
raffigurato strisciante ai suoi piedi nelle sembianze di serpente o drago. Nella
Qabbalah (v.) corrisponde alla bellezza, Tipheret, e domina la costellazione del
Leone, quale signore dell'elemento Fuoco (v.) che estende la propria
protezione alla relativa triade zodiacale (Ariete, Leone e Sagittario). Angelo
di Luce vincitore della Bestia, è da sempre considerato il capo delle schiere
celesti. L'imperatore Costantino I (v.) a partire dal 313 d.C. gli tributò un
culto intenso, fino a dedicargli il Micheleion,
un imponente santuario fatto costruire in Costantinopoli. Carlomagno (v.) gli
dedicò il Sacro Romano Impero, imitato poi dai sovrani francesi che, fino a
Luigi XIII, gli dedicarono il loro regno. Singolare e misteriosa la linea retta
con la quale sono collegabili tra loro i principali luoghi di culto dedicati a
M., tutti eretti sui resti di antichi templi pagani, in luoghi dove in qualche
modo si è manifestata la sua presenza. Tale linea, tracciata partendo dal Monte
Carmelo (Palestina) per finire sul Monte di San M. (Inghilterra sud orientale),
passa su Delos, Delphi, Monte Sant'Angelo (Gargano), Sacra di San M. (Valsusa)
e Mont Saint Michel (Francia nord orientale, imponendosi all'attenzione degli
studiosi di esoterismo. La sua interpretazione quale richiamo alla rettitudine
ed al rispetto assoluto delle Leggi di Dio, appare forse eccessivamente
superficiale e semplicistica, ma non è certo da escludersi. Essendo saggia
l'esclusione della casualità, essa mantiene ancora avvolto nel mistero il suo
reale significato (Gli Angeli fra noi,
di G. Dembech, Ediz. L'Ariete, 1993).
Microcosmo: Le
filosofie ermetiche identificano nell'essere umano il Microcosmo, in contrapposizione al
Macrocosmo con cui la Tradizione fa riferimento all'Universo, od addirittura alla
indefinita figura del Creatore, ovvero Dio. Secondo san Bonaventura (Itinerarium mentis
in Deum) l'uomo , o microcosmo, ha cinque sensi, che sono come cinque porte attraverso
le quali entra nella sua anima la cognizione di tutte le cose che sono nel mondo
sensibile. San Gregorio Magno (540-604) sosteneva che l'uomo, in un certo modo, è tutte
le cose, ovvero è un universo completo in miniatura. Egli racchiude in sé i diversi
ordini della natura. L'ordine minerale inanimato, l'ordine animato vegetale ed animale,
l'ordine spirituale comune agli uomini, agli angeli ed a Dio. Infine san Pier Damiani
riassume la tradizione in una formula che riconduce tutto all'essenziale: "L'uomo
è definito con un termine greco, microcosmo, ovvero mondo in piccolo, perché per la sua
essenza materiale egli è composto dagli stessi quattro elementi dell'universo. La stessa
pulsazione anima il grande corpo del mondo ed ognuno degli esseri che lo compongono.
Quest'onda portatrice del mistero della vita non ha come unico effetto quello di ritmare
nell'istante le gerarchie create. Spinge infatti davanti a sé, sull'infinita rotaia dei
tempi, l'incessante genesi degli esseri in divenire. Agli occhi di quest'uomo la medusa è
l'immagine infallibile di ciò che le cose sono state prima di essere come sono;
l'embrione che già preparava l'adulto, il mitico antenato che ha creato le tribù, e la
cui nascita ha segnato la prima organizzazione del Caos". Y
(Massoneria) Tentare l'identificazione di un essere perfetto, onnipotente ed onnisciente come la divinità viene da sempre riconosciuta impresa proibitiva per il piccolo elemento uomo. Non aiutano né la sua intelligenza né il suo impegno. L'unico approccio possibile viene dal principio esposto nella Tavola di smeraldo, attribuita ad Ermete Trismegisto (v.). È in quell'antico ed emblematico documento che viene indicata l'identità assoluta tra quanto sta in basso con quanto sta in alto, tra il piccolo ed il grande. In altri termini, insegna (ma è anche un monito) che per comprendere la natura del Grande Architetto dell'Universo occorre conoscere a fondo quella dell'essere umano. Eliminate scrupolosamente tutte le immense imperfezioni di quest'ultimo, ecco automaticamente definito Dio, e con Lui lo stesso Universo.
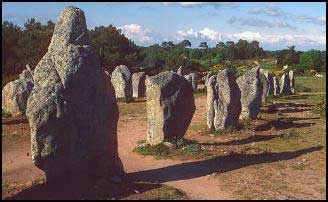 Menhir: Il
M. è una grossa pietra oblunga, piantata verticalmente sul terreno, mentre il dolmen è
costituito da tre pietre lunghe, due in verticale che reggono la terza, che è adattata a
tetto. Questi macigni vengono chiamati anche Megaliti (v.), dal greco megas,
(grande) e lithoz, (pietra). Li ritroviamo in tutta
Europa come semplici sassi isolati, oppure filari che rispondono ad una certa logica, o
ancora costruzioni complesse; di queste la più famosa è sicuramente quella di Stonehenge
(v.), in Gran Bretagna. I megaliti, collocati in genere dalle popolazioni locali, sono
antichissimi e la loro collocazione richiedeva una tecnica progredita. Noi siamo abituati
a considerare i nostri antenati europei come selvaggi che si limitavano ad andare a
caccia, vestirsi di pelli e mangiare carni crude ma in realtà erano capaci di pensare a
progetti ingegnosi e realizzarli. Infatti per mettere in verticale una pietra alta diversi
metri bisogna usare un sistema di cunei ed impalcature. Per fare poi un Dolmen
(v.), è necessario che l'impalcatura circondi tutto l'impianto. Per simili opere
servivano centinaia di uomini organizzati, e in questo senso è logico pensare a capi e
dipendenti, forse sacerdoti e fedeli, o forse scienziati in grado di farsi fornire
un'adeguata mano d'opera. Spesso i megaliti venivano trasportati da lontano, con zattere e
rulli, impresa questa non da poco considerando che in quelle epoche non era stata scoperta
ancora la ruota. Gli anni in cui cominciano a diffondersi i M. sono quelli del neolitico e
dell'età del bronzo. In Bretagna emergono pietroni innalzati duemila anni prima che gli
egiziani pensassero alle loro piramidi. In un sito chiamato Locmariaquer c'è poi il Gran
M., spezzato da un fulmine in quattro tronconi: in origine infatti pesava quasi 400
tonnellate, e per metterlo in piedi saranno occorsi certamente migliaia di uomini. Nella
campagna di Carnac sud bretone, migliaia di sassi furono allineati in file parallele per
centinaia e centinaia di metri mentre ad Avebury in Inghilterra sorgeva un cerchio di
megaliti, un centinaio almeno, simili a quelli di Stonehenge. Ma gli impianti più
affascinanti, oltre a quelli Britannici, sorgono a Malta: pilastri ciclopici che svettano
verso il cielo, mura e travi di marmo orizzontali che formano porte. E ancora camere
mortuarie in Irlanda, con i primi tentativi di formare una cupola o i megaliti sotterranei
dell'isola di Gavrinis, in Francia, dove ogni pietra è incisa con misteriosi motivi a
spirale o a zigzag od ancora i M. scolpiti della Corsica, che sono vere e proprie statue.
Opere queste affascinanti, che rivelano non solo conoscenze di ingegneria ma uno
straordinario senso artistico. Misteriosi i disegni, misteriosi gli scopi. A che cosa
dunque servivano queste costruzioni? Spesso erano monumenti funerari; alla base di molti
M. sono infatti stati trovati corpi di antichissimi defunti, anche famiglie intere. A
lungo si è creduto così che avessero una funzione religiosa, qualcuno ha anche parlato
per esempio dei Drudi e dei loro sacrifici umani. Ma in genere i megaliti risalgono ad
epoche molto anteriori. A Stonehenge le pietre sono disposte in modo da segnalare il
solstizio d'estate e la posizione più settentrionale della luna ogni 18 anni, al
solstizio d'inverno. Tenendo conto che in altre località molti M. sono stati spostati o
distrutti dalla mano dell'uomo, ci sono indizi che fanno pensare a calcoli sulle eclissi
di sole e di luna. Come spesso accadeva nei tempi remoti, è probabile che scienza e
religione andassero di pari passo. I sacerdoti erano infatti anche astronomi e astrologi,
ascoltati dai capitribù che fornivano gli uomini necessari per le grandi costruzioni
megalitiche. Misteriosamente però ad un certo punto, di colpo questa tecnica si estinse.
Anche di ciò non si conoscono le ragioni, ma forse gli impianti fissi non potevano
seguire gli spostamenti dell'arco celeste. Possiamo così immaginare ad esempio che un
sacerdote prevedesse un eclisse, e che questa non si sia verificata. Il popolo infuriato
decide così di distruggere l'osservatorio, non credendoci più. Questa è però solo
un'ipotesi come tante, ma d'altra parte per questi macigni sepolti nella terra e nel
tempo, tutto è limitato a pura ipotesi.
Menhir: Il
M. è una grossa pietra oblunga, piantata verticalmente sul terreno, mentre il dolmen è
costituito da tre pietre lunghe, due in verticale che reggono la terza, che è adattata a
tetto. Questi macigni vengono chiamati anche Megaliti (v.), dal greco megas,
(grande) e lithoz, (pietra). Li ritroviamo in tutta
Europa come semplici sassi isolati, oppure filari che rispondono ad una certa logica, o
ancora costruzioni complesse; di queste la più famosa è sicuramente quella di Stonehenge
(v.), in Gran Bretagna. I megaliti, collocati in genere dalle popolazioni locali, sono
antichissimi e la loro collocazione richiedeva una tecnica progredita. Noi siamo abituati
a considerare i nostri antenati europei come selvaggi che si limitavano ad andare a
caccia, vestirsi di pelli e mangiare carni crude ma in realtà erano capaci di pensare a
progetti ingegnosi e realizzarli. Infatti per mettere in verticale una pietra alta diversi
metri bisogna usare un sistema di cunei ed impalcature. Per fare poi un Dolmen
(v.), è necessario che l'impalcatura circondi tutto l'impianto. Per simili opere
servivano centinaia di uomini organizzati, e in questo senso è logico pensare a capi e
dipendenti, forse sacerdoti e fedeli, o forse scienziati in grado di farsi fornire
un'adeguata mano d'opera. Spesso i megaliti venivano trasportati da lontano, con zattere e
rulli, impresa questa non da poco considerando che in quelle epoche non era stata scoperta
ancora la ruota. Gli anni in cui cominciano a diffondersi i M. sono quelli del neolitico e
dell'età del bronzo. In Bretagna emergono pietroni innalzati duemila anni prima che gli
egiziani pensassero alle loro piramidi. In un sito chiamato Locmariaquer c'è poi il Gran
M., spezzato da un fulmine in quattro tronconi: in origine infatti pesava quasi 400
tonnellate, e per metterlo in piedi saranno occorsi certamente migliaia di uomini. Nella
campagna di Carnac sud bretone, migliaia di sassi furono allineati in file parallele per
centinaia e centinaia di metri mentre ad Avebury in Inghilterra sorgeva un cerchio di
megaliti, un centinaio almeno, simili a quelli di Stonehenge. Ma gli impianti più
affascinanti, oltre a quelli Britannici, sorgono a Malta: pilastri ciclopici che svettano
verso il cielo, mura e travi di marmo orizzontali che formano porte. E ancora camere
mortuarie in Irlanda, con i primi tentativi di formare una cupola o i megaliti sotterranei
dell'isola di Gavrinis, in Francia, dove ogni pietra è incisa con misteriosi motivi a
spirale o a zigzag od ancora i M. scolpiti della Corsica, che sono vere e proprie statue.
Opere queste affascinanti, che rivelano non solo conoscenze di ingegneria ma uno
straordinario senso artistico. Misteriosi i disegni, misteriosi gli scopi. A che cosa
dunque servivano queste costruzioni? Spesso erano monumenti funerari; alla base di molti
M. sono infatti stati trovati corpi di antichissimi defunti, anche famiglie intere. A
lungo si è creduto così che avessero una funzione religiosa, qualcuno ha anche parlato
per esempio dei Drudi e dei loro sacrifici umani. Ma in genere i megaliti risalgono ad
epoche molto anteriori. A Stonehenge le pietre sono disposte in modo da segnalare il
solstizio d'estate e la posizione più settentrionale della luna ogni 18 anni, al
solstizio d'inverno. Tenendo conto che in altre località molti M. sono stati spostati o
distrutti dalla mano dell'uomo, ci sono indizi che fanno pensare a calcoli sulle eclissi
di sole e di luna. Come spesso accadeva nei tempi remoti, è probabile che scienza e
religione andassero di pari passo. I sacerdoti erano infatti anche astronomi e astrologi,
ascoltati dai capitribù che fornivano gli uomini necessari per le grandi costruzioni
megalitiche. Misteriosamente però ad un certo punto, di colpo questa tecnica si estinse.
Anche di ciò non si conoscono le ragioni, ma forse gli impianti fissi non potevano
seguire gli spostamenti dell'arco celeste. Possiamo così immaginare ad esempio che un
sacerdote prevedesse un eclisse, e che questa non si sia verificata. Il popolo infuriato
decide così di distruggere l'osservatorio, non credendoci più. Questa è però solo
un'ipotesi come tante, ma d'altra parte per questi macigni sepolti nella terra e nel
tempo, tutto è limitato a pura ipotesi.

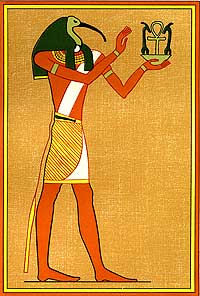
 Il metodo terapeutico adottato da M. suscitò notevole scalpore, incontrando la netta opposizione dell’ambiente scientifico e religioso di Vienna, per cui fu costretto a trasferirsi a Parigi (1778), dove ottenne fama e successo. Il metodo di M., noto come mesmerismo (v.), indubbiamente soggetto a suggestioni ed
abusi, nelle sue linee fondamentali è decisamente credibile, in quanto si tratta di una
terapia ancorata all’eterico, ovvero al campo delle linee di forza plasmatrice che
sostiene l’organismo ed il suo funzionamento. Esso è tradizionalmente inquadrato
nella medicina romantica di fine settecento, e rappresenta un'anticipazione delle moderne
posizioni dell'ipnotismo. M. aderì alla Massoneria, essendo accertato che sia stato
membro della Loggia esoterica dei Philadelphi di Narbonne.
Il metodo terapeutico adottato da M. suscitò notevole scalpore, incontrando la netta opposizione dell’ambiente scientifico e religioso di Vienna, per cui fu costretto a trasferirsi a Parigi (1778), dove ottenne fama e successo. Il metodo di M., noto come mesmerismo (v.), indubbiamente soggetto a suggestioni ed
abusi, nelle sue linee fondamentali è decisamente credibile, in quanto si tratta di una
terapia ancorata all’eterico, ovvero al campo delle linee di forza plasmatrice che
sostiene l’organismo ed il suo funzionamento. Esso è tradizionalmente inquadrato
nella medicina romantica di fine settecento, e rappresenta un'anticipazione delle moderne
posizioni dell'ipnotismo. M. aderì alla Massoneria, essendo accertato che sia stato
membro della Loggia esoterica dei Philadelphi di Narbonne.